-
.

Proponiamo un’interessante ricostruzione della Polizia dell’immediato dopoguerra in Trentino Alto Adige, curata da Cornelio Galas ed estrapolato da www.televignole.it/el-rebalton-in-trentino-11/L’ITALIA E I TRENTINI.
AUTORITÀ, FORZE DELL’ORDINE E POPOLAZIONE CIVILE
a cura di Cornelio Galas
Già nel corso delle giornate insurrezionali, ma soprattutto nell’immediato dopoguerra, si evidenziò l’esistenza in larghi settori della società civile trentina di un diffuso sentimento d’insofferenza, quando non di sostanziale opposizione, nei confronti dei rappresentanti dello Stato e delle istituzioni italiane. In realtà, tale atteggiamento ostile interessava chiunque fosse identificabile con l’autorità tradizionale – lo Stato – o con quella transitoria – i CLN. Partigiani, militari dell’esercito, carabinieri e guardie di finanza incarnavano una legittimità che o si stentava a riconoscere oppure era talmente screditata agli occhi della comunità da non godere alcuna stima. In tale contesto, incidevano sicuramente vent’anni di regime fascista, ma soprattutto la guerra da cui l’Italia era uscita sconfitta nonostante la partecipazione alla Resistenza, alla lotta di liberazione dal nazifascismo e la profonda crisi identitaria prodotta dal tracollo dell’8 settembre 1943.
Da questo punto di vista, l’indagine storica si è soffermata ad analizzare alcune questioni specifiche. Per taluni aspetti, la maggior parte degli studi si è rivolta ad indagare l’evento propriamente politico-militare, l’armistizio, la fuga della monarchia e di Badoglio, il traumatico sbandamento delle forze armate. Altre ricerche si sono soffermate sulle conseguenze morali, su quanto la cesura dell’8 settembre abbia effettivamente influito sulla capacità degli italiani di auto-percepirsi come tali e su quanto l’idea di nazione sia entrata in crisi a partire da questa data. «La morte della patria» scaturita dall’armistizio, per riprendere la formula adottata da Ernesto Galli della Loggia, incise profondamente sulla fiducia degli italiani nelle istituzioni e sul sentimento d’appartenenza alla comunità nazionale.
IN CRISI L’IDEA DELLA NAZIONE
Lo spartiacque del settembre 1943 segnò il momento più drammatico mai raggiunto nel corso dell’intera storia unitaria. Il suolo nazionale fu invaso e conteso da eserciti nemici e contrapposti, i soldati prigionieri dell’una o dell’altra parte, le risorse in diversa maniera sfruttate e depredate, la stessa nazione divisa al suo interno e «violentata» dalla guerra civile. La brutalità del conflitto, inoltre, si scatenò sulla popolazione civile attraverso i bombardamenti, le città sfollate, i rastrellamenti, le deportazioni e le stragi indiscriminate. L’essere stati in balia, tra il 1943 e il 1945, di diverse tipologie d’autorità, da quella tedesca a quella fascista, da quella alleata a quella partigiana, aveva condizionato profondamente la capacità del singolo di riconoscere e di riconoscersi in un quadro nazionale coerente e coeso.
Tale crisi, infatti, va molto al di là del lato politico-militare della sconfitta: non può essere spiegata esclusivamente con questo dato, così come – tanto meno – può essere identificata o assorbita in essa per intero. Al contrario, la crisi dell’idea di nazione si radicalizza in morte della patria, proprio perché in essa moltissimi italiani vedono e sentono coinvolto lo stesso vincolo di appartenenza ad una medesima comunità nazionale, nonché il senso di tale vincolo. Se ciò accade è perché vi è in origine, nel drammatico nodo di eventi dal ’43 al ’45 una crisi verticale che colpisce l’intero organismo statuale italiano, determinandone quasi – nei fatti, e soprattutto nell’immaginario – una virtuale scomparsa dalla scena.
Secondo Galli della Loggia, per comprendere realmente questi eventi bisognerebbe risalire alle origini della nazione italiana in quanto prodotto artificiale dello Stato piuttosto che il contrario. Una volta che quest’ultimo, a partire dal 1943, entrò in disfacimento, anche l’idea di nazione doveva conseguentemente risentirne. La questione interessò anche il Trentino dove, peraltro, l’Italia conosciuta era stata quella fascista e quest’immagine negativa si ripercuoteva inevitabilmente nel dopoguerra.
Il periodo transitorio dalla guerra alla pace, come si è visto nelle pagine precedenti, contribuiva a rendere la situazione instabile. Alle truppe angloamericane si mescolavano i reparti del «nuovo» esercito italiano a fronte di una presenza sentita ancora come minacciosa dei soldati tedeschi stanziati sul territorio. Gli stessi CLN, organi mediatori in questa delicata fase di passaggio, solo col tempo raggiunsero un certo grado di riconoscibilità per poi decadere rapidamente affidando ai partiti politici l’onere di educare alla democrazia e ricostruire moralmente la società.
Tutto questo doveva necessariamente ripercuotersi nel momento in cui, cessate le operazioni belliche, il governo di Roma attraverso i suoi rappresentanti più visibili ed identificabili riprese in mano gradualmente il controllo della provincia. La guerra, in generale, aveva provocato pericolosi moti disgregatori che rischiavano di dissolvere la compagine nazionale. Dalla Sicilia giungevano notizie sempre più allarmanti sull’attività del movimento indipendentista, mentre tutto il Meridione, attraverso l’Uomo qualunque di Giannini, si faceva portavoce di un aggressivo e virulento spirito di disaffezione nei confronti dello Stato e soprattutto dei partiti politici antifascisti. Pure nell’Italia settentrionale, dove più vive e intense erano state la lotta di liberazione e la Resistenza, i «toni antiromani» non erano rari, sovente ricollegabili alla delusione per un’azione epurativa e punitiva nei confronti di fascisti e collaborazionisti poco energica.
L’ASAR E LA VOGLIA DI AUTONOMIA
In Trentino, questo senso di estraneità nei confronti dello Stato si rivestì di altri aspetti che assunsero, a partire dall’estate del 1945, una chiara connotazione politica nel movimento dell’ASAR. In esso, confluirono le istanze di autonomia amministrativa nei confronti del governo centrale. Tuttavia, soprattutto nei primi tempi, si univano e sovrapponevano ad esse sentimenti indipendentisti e secessionisti, di vera e propria ostilità verso Roma ed i suoi esponenti istituzionali che sfociarono occasionalmente in manifestazioni anche violente di piazza. Alla base, vi era pure la malintesa sensazione, in una parte consistente ma indefinita dei militanti del movimento autonomista, che il fascismo, e quindi lo Stato, avesse coinciso con l’origine «meridionale» dei suoi funzionari. La protesta e l’insofferenza nei confronti dell’Italia e del governo centrale si rivestirono, purtroppo, anche di comportamenti ed espressioni razziste e xenofobe.
UNA NUOVA POLIZIA
Nei giorni dell’insurrezione, le formazioni partigiane (Brigata Eugenio Impera (Riva del Garda), Battaglioni Gherlenda (Tesino-Valsugana), Giannantonio Manci (Alta Anaunia), Giovanni Monteforte (Alta val di Non), Furlan (Alta Valsugana), Panarotta (Levico), Fabio Filzi (val di Non e val di Cembra), Manlio Longon (Trento e provincia), Epifanio Gobbi (Basso Sarca). Dal punto di vista numerico, si andava dai 130 partigiani della Brigata Impera alle poche decine delle altre formazioni. A questi reparti si univano distaccamenti, Gruppi d’azione partigiana (GAP) e Squadre d’azione patriottica (SAP), operanti per lo più nei principali centri urbani e dediti fino a quel momento ad azioni di sabotaggio e spionaggio. In Trento, Fondazione Museo storico del Trentino) che più o meno precariamente, avevano operato in Trentino nel corso dell’occupazione tedesca, uscirono allo scoperto. Gli organici si erano ampliati notevolmente grazie all’afflusso di patrioti e partigiani dell’ultima ora che portarono il numero complessivo dei componenti da 751 a 1.209. Alle unità partigiane propriamente trentine, per lo più «autonome», si aggiunsero altri reparti provenienti dalle regioni limitrofe. Ancora alla fine di maggio del 1945, il CLNP rilevava «i frequenti sconfinamenti da parte dei partigiani, specie di Belluno». Poco meno di un mese dopo, il liberale Umberto Corsini segnalava la penetrazione in Trentino attraverso il passo del Tonale di «milizie della provincia di Brescia». Le operazioni in cui furono impiegati i combattenti nella guerra di liberazione riguardarono in gran parte – per uno strano capovolgimento dei ruoli – il rastrellamento e la cattura di soldati tedeschi sbandati nella zona mistilingue e di confine con l’Alto Adige.
Tuttavia, soprattutto nei primi tempi, l’attività dei nuclei partigiani disseminati nei principali centri delle vallate trentine aveva suscitato numerose perplessità non solo tra gli alleati, ma anche tra i membri del CLNP. Nel maggio 1945, i meccanismi innescati dal conflitto e da due anni di occupazione militare tedesca nonché dalla guerra civile che aveva insanguinato metà del Paese erano ancora lontani dall’essere frenati. Il Trentino, pur non avendo vissuto il dramma dello scontro fratricida, non poteva dirsi immune dalle sue conseguenze. Anche nelle valli locali, il ritorno alla normalità risultava difficoltoso per gli odi e i rancori prodottisi negli anni precedenti. I «giovani partigiani», come si è visto, impersonavano così un certo desiderio di giustizia politico-sociale dovuto al caos dei primi momenti postbellici. Nella prima metà del maggio 1945, il CLNP segnalava il verificarsi di episodi «incresciosi […] ad opera di sedicenti patrioti: sostituzioni di persone, organizzazione di comitati, requisizioni ecc.», fatti non più tollerabili. «Disciplina e calma» dovevano rappresentare le parole d’ordine per i «veri partigiani» che, per un’epurazione reale ed efficace, avrebbero dovuto attendere le specifiche direttive del Comitato di Trento. La soluzione fu ricercata nella creazione di un Corpo di polizia partigiana avente un unico Comando provinciale con sede a Trento.
Gli agenti sarebbero stati scelti «tra i partigiani migliori di ciascun Comune». Il 10 giugno 1945, il CLN comunicò l’avvenuto scioglimento dei distaccamenti di polizia partigiana e la prossima costituzione di un Corpo provinciale. La decisione aveva ottenuto l’approvazione degli stessi ufficiali dell’AMG che, forse, intendevano così giungere a disarmare i partigiani nella maniera più rapida e indolore possibile. La questione, fin dal dicembre 1944, aveva rivestito per gli angloamericani un’importanza notevole legata ai timori che suscitava la presenza maggioritaria, nelle file partigiane, di elementi orientati in senso socialcomunista. Nel giugno 1945, si costituì a Trento un Comando militare provinciale con «funzioni di raccolta, assistenza e smobilitazione dei partigiani trentini». Composto da elementi già responsabili nelle Brigate partigiane Belluno e Garemi (La prima aveva operato nel Bellunese, la seconda, invece, a cavallo tra la provincia di Trento e quella di Vicenza. Sulla penetrazione di quest’ultima nel territorio trentino durante la guerra), assorbiva le competenze dell’Ufficio affari militari del CLN di Trento.
Tuttavia, secondo il tenente colonnello Gianfilippo Cangini (Ufficiale di carriera, medaglia di bronzo al valor militare. Partecipò alla campagna di Russia nei ranghi della Divisione di fanteria Pasubio e alla guerra di liberazione col Gruppo di combattimento Folgore ) del Gruppo di combattimento Folgore, sebbene l’AMG avesse a suo tempo ordinato il disarmo, alla data del 7 giugno 1945, la consegna delle armi da parte dei partigiani non era avvenuta. Pur mostrando di comprendere il «rincrescimento» in «chi per mesi e mesi» aveva «custodito queste armi con grave pericolo suo, dei suoi familiari e delle sue cose, e che le stesse armi» aveva «usato coscientemente contro il tedesco invasore», il colonnello invitava i CLN a rafforzare l’opera di persuasione.
In conclusione, l’ufficiale avvertiva che la detenzione di armi oltre il termine stabilito sarebbe stata severamente punita. Qualsiasi partigiano fosse stato trovato in possesso di armi sarebbe stato «considerato ribelle e non più patriota». Nel settembre 1945, il questore Pizzuto confermava che i «notevoli depositi clandestini di armi» che si erano costituiti in tutta la provincia erano fino a quel momento «sfuggiti alle ricerche della Polizia». Soprattutto, «il disarmo dei partigiani» non era avvenuto, né gli stessi cittadini avevano consegnato le armi da guerra come prescritto in un precedente «bando militare alleato». Nel gennaio 1946, i carabinieri scoprirono a Levico un deposito clandestino di armi e munizioni occultate dai partigiani. Con il graduale rafforzamento delle forze di polizia, nei mesi e negli anni successivi, si giunse alla scoperta di altri depositi d’armi.
La questione della consegna delle armi da parte degli ex partigiani, di ogni colore politico (L’opposizione a consegnare le armi non riguardava solo gli elementi comunisti, ma anche socialisti, democristiani o di altri orientamenti politici. Il disarmo imposto dagli alleati e dalle autorità governative risultò un fiasco soprattutto perché furono depositate solo armi inefficienti o antiquate mentre quelle più moderne – in particolare, quelle automatiche – furono rapidamente nascoste), si allargava al più ampio contesto dell’Italia settentrionale dove più forte e organizzato era stato il movimento di resistenza. Quello che più turbava i partigiani erano i tempi e i modi attraverso cui si svolgeva la smobilitazione che, spesso, era effettuata dagli angloamericani in maniera irriguardosa. Secondo Dondi, «il rapido disarmo […] è ritenuto offensivo dai partigiani» […] perché «l’arma è parte dell’identità partigiana, i resistenti che ne vengono privati si sentono, in un primo tempo, come mutilati».
LE ARMI (NASCOSTE) DEI PARTIGIANI
Alla base della tendenza partigiana a conservare in depositi segreti le armi «conquistate» nel corso della lotta (Attraverso la memorialistica risulta evidente la volontà dei partigiani di occultare il maggior numero di armi e munizioni possibile), stava pure la sfiducia ch’essi nutrivano verso un quadro politico generale non del tutto chiaro e definito. Per un verso, persisteva ancora il timore di un colpo di coda del fascismo e degli ambienti reazionari che potesse mettere in pericolo i successi ottenuti con la liberazione (Ancora nel maggio 1946, si segnalava anche in Trentino la probabile presenza di gruppi neofascisti dediti a recuperare armi). Per l’altro, una parte consistente del partigianato riteneva che l’ipotesi rivoluzionaria non fosse stata del tutto accantonata e attendeva solo l’«ora X». Lamberto Ravagni (Rovereto, 20 settembre 1926. Avvocato. Giovanissimo, era entrato nelle fila della Brigata Pasubiana partecipando alla lotta di liberazione. Nel dopoguerra, partecipò alla vita politica e culturale della provincia. Consigliere comunale di Rovereto per il PCI dal 1964 al 1978), dalle pagine di Liberazione nazionale, tendeva a sottolineare soprattutto il primo aspetto.
Forse che noi non si voleva consegnare le armi? Noi non siamo dei militari di professione, noi non adoriamo le armi come tali, ma le concepiamo solo contro la prepotenza delle armi altrui. Eppure le amavamo, perché erano state nostre compagne per mesi e mesi, perché le avevamo conquistate col sangue nostro e dei nostri compagni, perché ci ricordavano i migliori. Era un sacrificio duro al quale però eravamo preparati. […] E questo sacrificio era ancora più duro, perché vedevamo il fascismo non ancora morto, e che non si aveva nessuna volontà di far morire.
Una varietà di sentimenti che impediva un rapido ritorno alla normalità. Anche in Trentino, l’atteggiamento ambiguo assunto dagli alleati nei confronti dei partigiani e dei partiti di sinistra era condiviso in maniera sostanziale dai funzionari del governo centrale e dalle formazioni moderate, DC e PLI, dello stesso schieramento ciellenistico.
La situazione di estrema confusione seguita alla cessazione delle ostilità – dove pure i partigiani o presunti tali avevano le proprie responsabilità – veniva usata in maniera strumentale da alleati e rappresentanti istituzionali a fini eminentemente politici. Secondo Pizzuto, la Polizia partigiana inizialmente non aveva incontrato il favore della popolazione. «Le perquisizioni arbitrarie, con incerta sorte di molto materiale requisito, arresti talvolta corrivi e determinati da rancori o in genere da motivi personali, dicerie di enormi ammassi di materiali più o meno saccheggiati e riposti in città e montagna, contegno aggressivo di molti elementi» avevano contribuito ad alienare «le simpatie generali dal reparto».
In parte ciò era dovuto al fatto che ai partigiani trentini si erano aggregati «elementi equivoci, piombati all’ultimo momento autodichiarandosi partigiani di brigate delle quali si udiva il nome per la prima volta dalle loro bocche». Un giudizio negativo che lo stesso questore Pizzuto rivide però due mesi dopo segnalando i buoni risultati raggiunti dalla polizia partigiana nel servizio d’ordine pubblico. Con un Comando provinciale forte di 150 uomini, la Polizia partigiana fu riorganizzata con «distaccamenti […] costituiti a Rovereto, Riva, Tione e Cles» incaricati «di presidiare i posti di blocco dislocati ai limiti della provincia allo scopo di impedire l’esportazione dei prodotti contingentati» e «nei servizi di vigilanza, di ordine pubblico, di piantonamento e di rastrellamento».
Il risultato di questa capacità operativa poteva dirsi «soddisfacente» e migliorabile se il corpo fosse stato debitamente guidato e inquadrato «nei servizi tecnici ausiliari». Nel settembre 1945, avere a disposizione una forza di polizia in grado di ottenere qualche successo si dimostrava ancora di una certa utilità a fronte di una pressoché completa disorganizzazione degli organi di pubblica sicurezza tradizionali. Pizzuto segnalava che «a causa della nota deficienza numerica del personale e più ancora per l’assoluta mancanza di mezzi adeguati» non era stato possibile «effettuare quelle operazioni di rastrellamento e di ricerca che essa [la Polizia] si era proposta di condurre a termine nel periodo che ha immediatamente seguito la fine della guerra». Nel caso in cui si fossero ripetute le manifestazioni di malcontento sociale verificatesi alla metà di settembre, la questura avrebbe potuto mettere in campo «si e no una decina di agenti». Alla carenza di personale, faceva riscontro la debolezza organizzativa e d’equipaggiamento.
Le forze disponibili a tutela dell’ordine pubblico sono inadeguate alla bisogna, non tanto per la loro consistenza numerica, che è assai ridotta, quanto per l’insufficienza di mezzi e armamenti. Soltanto un terzo degli agenti della questura è armato di pistola. In tutta la questura esistono soltanto tre mitra. Il resto della forza è armato di moschetti e le disponibilità di munizioni sono molto scarse.
I primi governi del dopoguerra, di fatto, cercarono di supplire alle lacune strutturali della polizia permettendo l’afflusso nei suoi organici di «un numero considerevole di ex partigiani». Nell’agosto 1945, circa sei mila combattenti per la libertà entrarono nelle forze di pubblica sicurezza. Poco tempo dopo, nel marzo 1946, un bando ministeriale metteva a disposizione altri 15 mila posti per ufficiali ed agenti ausiliari. Tale scelta rifletteva la necessità sia di sostenere economicamente chi aveva combattuto contro il nazifascismo sia di controllare, contemporaneamente, quegli elementi partigiani ritenuti più imprevedibili. All’indirizzo governativo, di natura pragmatica, si aggiungeva quello più politico dei partiti di sinistra che consideravano l’immissione dei partigiani negli organi di polizia come lo strumento più adatto a «democratizzarli», utile a controbilanciare l’Arma dei carabinieri percepita come filo-monarchica se non reazionaria. A frustrare la speranza di creare una forza di sicurezza democratica stavano difficoltà di carattere oggettivo difficilmente superabili. Localmente, la Polizia partigiana aveva «dato ottime prove cooperando validamente con le altre forze di polizia al mantenimento dell’ordine, grazie allo spirito garibaldino fresco e spontaneo dei suoi componenti».
Proprio questo spirito suppliva alle manchevolezze di natura «tecnica» visto che «il male che minava la compagine era proprio la mancanza di ufficiali istruiti, competenti e capaci di imporre la necessaria disciplina». Nella relazione inviata al presidente del CLNP Benedetti nel novembre 1945, Pizzuto osservava che «il Comando» era «diventato poco alla volta un insieme di elementi discordi». La mancanza di competenze faceva «trascurare la contabilità e i principi di una sana amministrazione specie nel movimento di denaro e così ci si [trovava] di fronte ad accuse mosse dagli agenti nei riguardi dei comandanti». La penuria di fondi e finanziamenti indusse di conseguenza il comando «a licenziare e a ricollocare nella vita civile molti partigiani» che erano così andati ad ingrossare «la già lunga schiera di disoccupati». Ciò aveva prodotto «un forte malcontento tra i partigiani» che erano ritornati «alle loro case asportando le armi». La soppressione dei posti di blocco (In realtà, si trattava di una sospensione momentanea. I posti di blocco furono definitivamente aboliti nel novembre 1947) ai confini della provincia, nel novembre 1945, aveva contribuito ad avvilire ulteriormente gli agenti della Polizia partigiana aggravando la situazione.
Preoccupati del loro avvenire, non compiono più alcun servizio, non trovano facilmente il rancio e sono accasermati in locali freddi e privi di vetri, […] essi chiedono: 1) – un’inchiesta sull’operato del Comando […] 2) – la nomina di una commissione che possa studiare le necessità della Polizia Partigiana […] 3) – la regolare corresponsione delle paghe e stipendi 4) – il ritorno degli elementi licenziati e un’accurata selezione di tutti.
In questo caso, come in altri analizzati in precedenza, risulta che, nel mutare il quadro di istituzioni ed apparati preesistenti, il fallimento dei principali organismi nati dalla Resistenza derivava non solo dalle condizioni di difficoltà materiale del dopoguerra, ma dalla loro stessa impreparazione tecnica, dalla fragilità professionale e di competenze. Il carattere eterogeneo e politicamente connotato dei partigiani «incideva negativamente sulle capacità operative del Corpo».
TORNANO I “VECCHI” POLIZIOTTI
A partire dal secondo governo De Gasperi (10 luglio 1946-28 gennaio 1947), si evidenziò la tendenza ad affidarsi «al tradizionale modello italiano della pubblica sicurezza, e cioè di una polizia militarizzata, centralizzata, e sotto stretto controllo del governo»43. Dopo il massiccio arruolamento di ex partigiani del periodo 1945-1946, si assistette alla loro graduale sostituzione con militari dell’esercito italiano che avevano partecipato alla guerra di liberazione nel CIL o nei Gruppi di combattimento e di agenti e ufficiali della ex Polizia dell’Africa italiana (PAI) (Il Corpo di polizia coloniale, poi Polizia dell’Africa italiana, fu istituito nel 1936 a seguito di una riorganizzazione dei reparti di pubblica sicurezza operanti nel territorio della Libia, a presidio del governatorato italiano in Etiopia e delle colonie dell’Africa orientale italiana (AOI). Il nuovo corpo era alle dirette dipendenze del ministero delle colonie, poi rinominato in ministero dell’Africa italiana, ed era questo il primo caso in Italia di una forza armata dipendente da un ministero civile. Reparti operativi erano presenti anche sul territorio nazionale. All’8 settembre, alcuni di questi combatterono nella difesa di Roma permettendo la fuga del re e del governo verso sud. Altre unità, rimaste di stanza nell’Italia settentrionale dominata dai tedeschi e dalla RSI, furono assorbite nella GNR. Scioltasi nel 1945, centinaia di suoi elementi furono poi immessi nella Polizia a partire dal marzo 1946).
Specialmente in quest’ultimo caso, si trattava ancora una volta di personale educato dal fascismo che aveva fatto carriera nel corso del Ventennio. L’epurazione attuata tra guerra e dopoguerra dai governi di unità nazionale si risolse in un nulla di fatto tanto che l’evidente «coinvolgimento di tutte le forze di polizia nella repressione politica» attuata «durante il fascismo fu […] negato dai governi succedutisi dopo l’armistizio e […] largamente rimosso dall’immagine e dall’autoimmagine delle forze di polizia». Gli apparati di pubblica sicurezza non furono né riformati né riorganizzati in maniera tale da rappresentare «la continuità degli uomini e dell’istituzione».
L’arrivo del democristiano Mario Scelba (Caltagirone, 5 settembre 1901-Roma, 29 ottobre 1991. Ministro dell’interno, tranne brevi intermezzi, dal febbraio 1947 al luglio 1955. Presidente del Consiglio dei ministri dal febbraio 1954 al luglio 1955) al ministero degli interni comportò una rapida ed energica «contro-epurazione» dai ranghi delle forze armate e della polizia degli elementi partigiani precedentemente arruolati e una diversa riorganizzazione dei reparti delle forze dell’ordine. Ciò che si voleva raggiungere al più presto era una forza stanziale e di pronto intervento (Ad esempio, i reparti Celere, ossia unità mobili, dotate di automezzi e autoblindo, in grado d’intervenire rapidamente. Organizzati nel 1946 dal ministro degli interni dell’epoca, il socialista Giuseppe Romita (Tortona, 7 gennaio 1887-Roma, 15 marzo 1958), avrebbero dovuto sovrintendere alle elezioni politiche del giugno 1946) garante dell’ordine pubblico, rivolta, soprattutto, al «nemico interno» identificato nei partiti e nelle organizzazioni politiche di sinistra – PCI e PSI. Su tale indirizzo incidevano il timore di un’insurrezione armata comunista e lo scontro ideologico tra Est e Ovest che stava rapidamente evolvendo nella guerra fredda.
È significativo, tuttavia, che nell’opera di controllo e repressione venissero utilizzati quegli stessi elementi che, durante la dittatura, avevano operato contro l’antifascismo clandestino e che, nel dopoguerra, erano nuovamente legittimati nell’uso della forza e delle armi da fuoco nell’ambito dello Stato repubblicano e democratico. Il reclutamento o il mantenimento in servizio di personale non epurato e l’utilizzo dello stesso in funzione anticomunista favorì il permanere di «una mentalità con forti tratti autoritari», lontana dai valori della Costituzione repubblicana. Scelba incentivò la fuga dei partigiani dalle forze di polizia allettandoli economicamente con la promessa di «una buonauscita corrispondente a sei mesi di salario», un espediente che deludeva le aspettative di guadagnare alla causa repubblicana una polizia veramente democratica. Nel dicembre 1946, le disposizioni legislative studiate dal governo e in corso di approvazione suscitavano il commento amareggiato ma lucido di un partigiano trentino.
Pensavamo che per i funzionari fascisti, per gli sgherri repubblichini, quelli che avevano imprigionato, torturato, mandato in Germania i combattenti della libertà, fossero chiuse almeno le porte della polizia popolare e democratica. Invece, in questi giorni, un soffio di fascismo ritorna sulla polizia. […] Ma in fin dei conti è il governo che avvalla questa trasformazione antidemocratica della polizia. Contro tutte le promesse […] fatte davanti al Paese, all’ANPI nazionale, ecco uscire un abilissimo decreto che tende a ridurre da quindicimila a cinquemila gli agenti, sottufficiali e ufficiali partigiani e reduci nella Polizia del Paese. Nel decreto si parla di concorsi, di titoli di studio, di corsi d’addestramento, tutte cose già chieste dai partigiani stessi, appunto perché sono essi i primi a chiedere di adempiere sempre con più competenza alle proprie mansioni. Ma i provvedimenti sono combinati in modo che non possono giovare ai partigiani ed anzi li obbligano a dare le loro dimissioni o ad essere scartati. […] E per prendere con l’acqua alla gola questi giovani, l’abile formulatore del decreto, ha promesso pure lo stipendio per sei mesi a quegli agenti che se ne andranno in questi giorni.
Di fronte alla continua riassunzione in servizio di «repubblichini» e «fascisti» e «all’estremo tentativo di essere tutti liquidati, e mentre si [buttava] loro come un osso sei mesi di stipendio», gli agenti della polizia ausiliaria – partigiani, reduci – si rivolgevano al Paese e al governo «per sapere se la Repubblica popolare» volesse «o no una polizia democratica». Ben prima dell’avvento di Scelba, comunque, gran parte dei partigiani che erano entrati quali agenti ausiliari nelle forze di polizia ne erano usciti perché insofferenti al clima che si respirava nel Corpo (Nel 1950, gli ex partigiani in servizio effettivo nella Polizia di sicurezza assommavano a 4.777). Nei ricordi di quel periodo, Enno Donà descriveva come fosse generalmente difficile far apprendere agli ex combattenti il senso di una certa disciplina militare. «Ordinai anche di fare un’ora al giorno di ordine chiuso. Nacque il mugugno: Fox (Nome di battaglia di Donà) è il solito militare e non dimentica di esserlo, bisogna farlo fuori (scherzando)». Un mugugno che, tuttavia, rendeva esplicita anche nel partigianato trentino l’avversione e la diffidenza per qualsiasi forma d’organizzazione militare. D’altronde, l’esperienza partigiana era nata innanzitutto come renitenza alla leva, alle chiamate nell’esercito della RSI e nelle forze armate tedesche. In generale, la scelta di portarsi sulle montagne aveva comportato l’assunzione nei «renitenti/disertori» di una posizione assolutamente contraria alla guerra.
Solo il passare dei mesi e l’adesione alla causa della Resistenza avevano modificato tale decisione in un gesto autenticamente politico e trasformato i renitenti/disertori in «partigiani». Si trattava, per usare le parole di Marco Mondini e Guri Schwarz, di un «diffuso antimilitarismo» che, già presente durante la guerra di liberazione, si ripresentava a guerra finita quale «sintomo e spia di un rifiuto più propriamente politico dell’istituzione militare, percepita quale incarnazione di quello Stato che si aspirava a riformare radicalmente». La polemica antimilitarista fu ripresa, ad esempio, attraverso le pagine de Il Proletario, organo a stampa della Federazione trentina del PCI. In un articolo pubblicato il 17 novembre 1945, si ponevano alcuni dubbi sull’effettiva utilità di un esercito in Italia di fronte ad un’esistenza quotidiana precaria.
Ogni uomo di buon senso dovrebbe avere il diritto di credere che in Italia di forze armate ne abbiamo avute abbastanza. Ma da qualche mese sta succedendo esattamente il contrario. […] Camionette, vetture, motociclette, autoveicoli di tutti i tipi scorrazzano giornalmente e sempre in maggior numero e sempre vuoti sulle nostre strade; gli incidenti si succedono con ritmo impressionante; davanti ai bar […] la sosta delle macchine militari è immancabile; la gente passa, vede […] e pensa. Pensa che non ci sono carburanti e gomme per il trasporto delle farine, della carne e della legna, paga le tasse per mantenere l’esercito e si chiede cosa serva questo schieramento inutile di forze armate. L’ordine pubblico è affidato a sparute forze di polizia che fanno tutto il loro meglio per arginare l’ondata di furti e rapine che aumenta con impressionante livello, ma non ce la fanno. Girano invece giornalmente per la città le ronde militari fornite di armi automatiche, ma che però non prestano servizio di polizia.
Le disastrose sconfitte subite nel corso del conflitto 1940-1943, il traumatico armistizio e la fuga del re avevano «determinato», peraltro in tutta la società italiana e non solo negli ambienti di sinistra, «un atteggiamento di rifiuto per qualunque accenno a tematiche di carattere militare», anche in considerazione del fatto che esistevano «problemi più gravi per il presente e l’avvenire del paese». Era dunque logico che tali posizioni, assunte dal partito che più aveva contribuito alla Resistenza, si rispecchiassero nei partigiani che avevano fatto e facevano riferimento ad esso.
Del resto, l’8 settembre 1943 gran parte dell’esercito italiano si era sbandato lasciando il Paese alla mercè dell’invasore tedesco. La lotta di liberazione, impersonata dai partigiani, continuava ad avere per questi un alto valore di riscatto dal disastro dell’armistizio (Il «ripudio del Regio esercito» che riguardava sia i partigiani sia i militi della RSI, inequivocabilmente connesso con la percezione d’essere stati traditi). L’auto-rappresentazione dei partigiani in quanto unici depositari della vittoria ottenuta sul nazifascismo si riproduceva, nell’immediato dopoguerra, in un confronto con i militari del «nuovo» esercito italiano. D’altro canto, questi ultimi non nascondevano atteggiamenti e comportamenti chiaramente fascisti che irritavano enormemente i partigiani e, in qualche occasione, anche la popolazione civile. Nel medesimo articolo de Il Proletario, gli autori s’interrogavano sul senso della loro presenza.
Ed allora che cosa ci stanno a fare? Forse a cantare: Giovinezza come è successo sere or sono al Bar 3 Novembre sul Corso omonimo o a imbrattare i muri con le scritte W il Duce? Il popolo italiano di eserciti ne ha abbastanza […]. È arcistufo di divise, di medaglie, di speroni, di cinturoni, di trombe squillanti, labari e bandiere e relative parate. Il popolo italiano esporterebbe volentieri e gratuitamente generali e strateghi. C’è una nausea insopprimibile per la divisa.
Bisogna tener presente che, proprio in Trentino-Alto Adige, a partire dal giugno 1945, era stato dislocato il Gruppo di combattimento Folgore (Oggi Brigata paracadutisti Folgore. Pur avendo fornito prove di alta professionalità nel corso delle principali missioni di pace condotte all’estero a partire dal Libano, nel 1982, militari appartenenti al reparto si sono resi responsabili di torture e sopraffazioni a danno di prigionieri durante l’operazione Restore hope in Somalia, tra il 1992 e il 1993. Sull’esistenza, nella Brigata, di un universo valoriale e di uno spirito di Corpo che fa esplicito riferimento al fascismo e alla RSI, la ricerca non riesce ad andare al di là di una visione macro, limitandosi a ricostruzioni generali), composto in massima parte da unità di paracadutisti le cui radici simboliche e valoriali si rispecchiavano nella matrice fascista. Nonostante l’afflusso nei Gruppi di un cospicuo numero di volontari e di partigiani, gli organici erano costituiti in larga parte da soldati e ufficiali del Regio esercito che avevano partecipato alle operazioni belliche prima del settembre 1943. Non era dunque un caso che, soprattutto in Alto Adige, si verificassero nel dopoguerra «alcuni atti d’indisciplina e di illegalità commessi dai reparti della Folgore […] a danno delle popolazioni di etnia tedesca».
SOLDATI CONTRO PARTIGIANI
La contrapposizione soldati/partigiani si evidenziò in alcuni episodi violenti anche in Trentino. A Trento, alla vigilia di Natale del 1945, si verificò un incidente tra partigiani e militari. Pochi mesi dopo, il 30 aprile 1946, a Riva del Garda si scatenò una rissa tra ex partigiani riuniti per festeggiare l’anniversario della Liberazione e due soldati della Friuli, ubriachi. Episodi assimilabili a quanto accadeva nel resto del territorio nazionale dove l’ordine pubblico stentava a ritornare sotto controllo. Gli stessi partigiani erano rappresentanti di un’autorità – i CLN prima, la questura poi – che si stentava a riconoscere ed erano considerati in maniera contraddittoria dalla stessa popolazione trentina.
Nel maggio 1945, il presidente del CLN di Roncegno invocava «la costituzione di un corpo di Polizia partigiana […] con elementi ben scelti per precedenti, qualità morali e fisiche, formato da partigiani che» avevano «realmente lottato e combattuto per il nostro movimento di Liberazione nazionale». In altre zone, l’atteggiamento della popolazione nei confronti degli ex partigiani si rivestiva di connotati più ostili che traevano però origine dagli episodi finali della guerra culminati, ad esempio, nelle stragi della val di Fiemme. Tale visione negativa era suffragata, in parte, da alcune azioni illegali compiute nell’immediato dopoguerra, che rivelavano una certa difficoltà a rientrare nella vita civile. Michele A. (Trento, 8 marzo 1912. Ex comandante della Polizia partigiana ausiliaria) e Pio M. (Vigo Meano, 14 novembre 1920. Ex agente della Polizia partigiana), agenti della polizia ausiliaria, furono giudicati per «concussione aggravata» a danno di alcuni cittadini, residenti per lo più nella zona mistilingue. Nel novembre 1945, Goffredo Psenner era stato fermato mentre trasportava un carico di mele senza alcuna autorizzazione o permesso di circolazione.
Per evitare la denuncia, Goffredo diede agli agenti oltre sette mila lire. Alcune settimane dopo, il 27 dicembre 1945, Luigi Nicolussi ricevette la visita di alcuni agenti partigiani che perquisirono la sua abitazione di Termeno in cerca di armi. Nel corso del processo, la Corte sottolineò che, «in quei tempi e in quella zona [mistilingue], se ne dovessero trovare, perché non erano infrequenti le sparatorie che, ogni tanto, avvenivano». Gli agenti rinvennero effettivamente una pistola, ma confidarono a Nicolussi che, se avesse pagato una certa somma, non lo avrebbero denunciato – la pistola, con tutta probabilità era stata ritrovata appositamente. Si trattava per lo più di reati di lieve entità, forse indotti dalla difficile situazione economica che anche gli agenti della Polizia partigiana attraversavano. Inoltre, l’area in cui questi episodi si verificarono aveva rappresentato e rappresentava ancora in quel secondo dopoguerra uno snodo di tensioni etniche e nazionalistiche che la guerra aveva aggravato. Tuttavia, rimaneva il fatto che queste «operazioni» di polizia non contribuivano a migliorare l’immagine dei poliziotti partigiani agli occhi della comunità civile.
Più o meno negli stessi giorni, la Polizia partigiana fu l’obbiettivo di due attentati. Nel novembre 1945, «una bomba ad alto potenziale» fu lanciata nella sede del distaccamento di Rovereto senza provocare vittime. Nonostante la pronta reazione degli agenti che «subito dopo lo scoppio sparavano […] alcuni colpi di mitra», gli autori riuscirono a dileguarsi nella notte. A Trento, il partigiano Rolando Doglioni fu oggetto di «due colpi di pistola per fortuna andati a vuoto da parte di […] sconosciuti». L’ex partigiano e vice sindaco di Riva, Romolo Crosina, nell’aprile 1946, ricevette la visita di tre individui, di cui uno armato di rivoltella, che lo derubarono di tre mila lire e del manoscritto che stava scrivendo sulla sua esperienza partigiana. Queste azioni, con tutta probabilità, non nascondevano motivazioni politiche specifiche, ma rappresentavano episodi casuali di delinquenza comune. È soprattutto nei confronti dei tradizionali rappresentanti dello Stato che la comunità trentina rese maggiormente evidente un sentimento di ostilità e disaffezione.. -
.
Leggo ora questo articolo e pur riconoscendone l'interesse e la documentazione, ritengo doverosa una precisazione in merito all'affermazione "esistenza, nella Brigata Paracadutisti Folgore, dell'"esistenza, di "un universo valoriale e di uno spirito di Corpo che fa esplicito riferimento al fascismo e alla RSI" , precisando poi che "la ricerca non riesce ad andare al di là di una visione macro, limitandosi a ricostruzioni generali". Trovo il tutto abbastanza grave e denigratorio, come a dire: <<affermo che è così ma non riesco a comprovarlo>>. Comunque........andiamo avanti.....Non mi soffermo sul valore dimostrato dai componenti della Brigata Folgore nelle missioni di pace in Libano ed in Somalia, dove lo ricordo, sono caduti soldati di leva. Per quanto riguarda gli abusi indubbiamente accertati, la stessa Commissione Parlamentare d'Inchiesta GALLO incaricata nel 1997 dal governo Prodi di far luce su questi eventi, giunse alla conclusione che “Gli episodi di maltrattamenti e torture ci sono stati, ma sono stati episodi del tutto individuali, che non hanno interessato lo spirito generale della missione e non hanno coinvolto tutto il contingente e taluni corpi”. Il Gruppo di Combattimento "Folgore" a cui fa cenno l'articolo che ebbe assegnati i poteri militari dell’Alto Adige era così composto: Reggimento paracadutisti Nembo, Reggimento Marina San Marco, Reggimento artiglieria, Battaglione misto del genio, Servizi. Quindi non solo paracadutisti. Da notare che i paracadutisti del Reggimento Nembo combatterono inquadrati nel Corpo Italiano di Liberazione e liberarono Bologna dopo un durissimo combattimento conclusosi con un corpo a corpo all'arma bianca contro i temibili Grune Teufel, i Diavoli verdi, paracadutisti germanici, nella località periferica Case Grizzano, tanto che l'Unità nei giorni successivi titolava in prima pagina a caratteri cubitali "GRAZIE PARACADUTISTI". Quindi: 1) L'Autorità militare nel 1945 in Alto Adige non era costituita solo da Reparti Paracadutisti ma era una Grande Unità mista. 2) Attribuire quindi episodi di violenza od abusi commessi in quel periodo ad un presunto diffuso sentimento fascista di ostilità verso le popolazioni germanofone presente nel Reparto appare una deduzione totalmente arbitraria non comprovabile. 3) Identificare gli appartenenti alla Brigata Paracadutisti "Folgore" come portatori "di un universo valoriale e di uno spirito di Corpo che fa esplicito riferimento al fascismo e alla RSI" risulta parimenti gratuitamente denigratorio proprio in quanto non comprovato. A meno che non si vogliano considerare come valori fascisti quel "cemento" che è lo spirito di corpo o l'attribuzione formale della continuità delle tradizioni della Specialità Arditi della Prima Guerra Mondiale al IX° Reggimento "Col Moschin"...... .
Trentino Alto Adige: "el rebaltòn", la polizia partigiana e il dopoguerra |
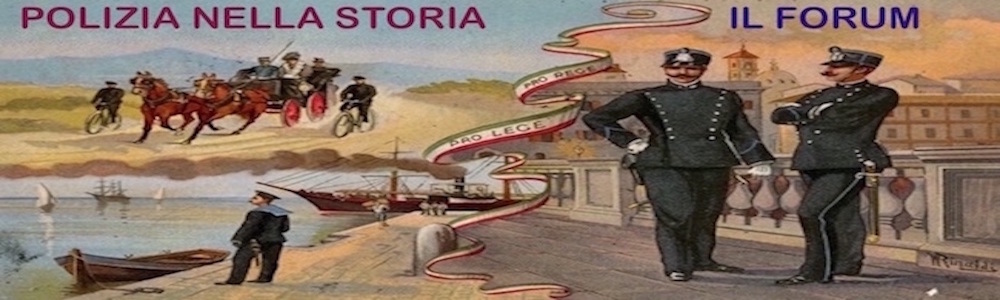




 Anonymous
Anonymous