|
|
|
E’ con immenso piacere che la Redazione di Polizianellastoria pubblica uno dei documenti sicuramente più importanti sotto l’aspetto storico: l’intervista effettuata dal nostro collaboratore esterno Fabrizio Gregorutti a uno degli ultimi reduci della Polizia dell’Africa Italiana, il signor Nicola Colucci. Tale intervista offre uno spaccato di prima mano su una delle realtà meno conosciute della Polizia italiana reso da uno dei diretti protagonisti che con lucidità e obiettività ci ha reso partecipi delle proprie vicissitudini personali e professionali nelle Colonie dell’Impero.
La Redazione ringrazia immensamente il signor Nicola Colucci e i suoi Familiari per l’esclusiva opportunità di poter tramandare ai posteri ciò che nessun libro potrà mai contenere: la testimonianza di chi era di persona sul campo.
Un ringraziamento particolare a Fabrizio Gregorutti per il certosino lavoro effettuato.
INTERVISTA CON LA GUARDIA P.A.I. NICOLA COLUCCI
(effettuata il 7 maggio 2012 nell’abitazione della guardia Colucci)
a cura di Fabrizio Gregorutti

L’ARRUOLAMENTO E LA GUERRA
Entrai nella PAI all’inizio del 1942, ad appena 18 anni. A quel tempo vivevo ancora a Trani, la mia città d’origine dove lavoravo come scalpellino. Un giorno mio zio venne a casa mia e senza tanti preamboli mi disse “C’è un concorso per l’arruolamento nella Polizia dell’Africa Italiana. Perché non fai la domanda?”.
Io accettai con entusiasmo. L’idea di arruolarmi in un Corpo così prestigioso mi piaceva e poi c’era l’Africa, che mi affascinava. Infatti ad appena 14 anni nel 1938 ero già stato in Egitto a lavorare come scalpellino e mi sarebbe piaciuto ritornarci.
E così presentai la mia brava domanda e poco tempo dopo, nel marzo del 1942, mi presentai a Tivoli, alla Scuola di Polizia dell’Africa Italiana.
Ricordo che noi neoarruolati ci schierammo nel piazzale dove venimmo passati in rassegna dal comandante della scuola, il generale Gazzola e dallo stesso comandante del Corpo, il generale Riccardo Maraffa che, dopo la rassegna ci convocarono in un ufficio, per un colloquio finale con noi. Entrambi i due alti ufficiali mi fecero una grande impressione, ma fu Maraffa che mi colpì immediatamente. Era un grand’uomo che incuteva rispetto non con il suo grado, ma con la sua umanità. Mi chiese con tono cordiale “Avete capito che non resterete in Italia, ma sarete destinato in Africa?” “Signor generale – risposi- è quello che voglio!” gli raccontai di quando ero andato in Egitto, prima della guerra, e di quanto mi avrei voluto tornare laggiù. Il generale sorrise e quel sorriso segnò il mio ingresso nella PAI.
L’addestramento fu duro. A parte le marce e l’addestramento militare, c’era un’abitudine tipica della Scuola di Tivoli, cioè quella della discesa con la corda dal terzo piano della caserma, prima di recarsi in piazzale per l’alzabandiera. Era una vera e propria tradizione della Scuola alla quale nessuno di noi allievi poteva sottrarsi e che fondamentalmente mi divertiva, per quanto fosse non priva di rischi. Ci fu un allievo, un ragazzo di Cerignola, che durante questa discesa con la corda si massacrò letteralmente le mani. Lo portarono all’ ospedale militare e da allora non ne ebbi più notizia. Io invece divenni un asso, anche perché i più bravi a scendere dalla corda si guadagnavano come premio la libera uscita, la ricompensa per noi più ambita.
Ci fu poi l’addestramento alle arti marziali, alla cosiddetta “Scuola di Karatè” di cui era responsabile un brigadiere veneto. Rimediavo un sacco di botte, ma non mi tiravo mai indietro, quando si trattava di offrirsi come volontario per le esercitazioni. Il brigadiere dovette rimanerne impressionato, perché ad un certo punto mi chiese “Colucci, ma tu non ti spaventi mai, con tutte le botte che prendi da me?” “Brigadiere – risposi- io voglio imparare!” il sottufficiale scoppiò a ridere “Hai ragione tu!”.
C’era poi l’addestramento più teorico, quello sui codici, ma anche su come trattare con i civili, sia i coloni italiani, che gli indigeni. Furono lezioni importanti, che mi permisero di affrontare al meglio quello che accadde nei mesi successivi.
I rapporti con la Polizia di Stato di allora, il Corpo degli Agenti di PS, erano inesistenti se non per la provenienza di alcuni degli ufficiali e dei sottufficiali, specialmente quelli della Scuola di Tivoli, mentre in Africa gli ufficiali erano per la maggior parte provenienti dal Regio Esercito.
Quando terminai il corso, ricevetti l’assegnazione al Battaglione “Romolo Gessi”, in servizio in Africa settentrionale.
Prima però insieme agli altri giovani agenti neoarruolati raggiunsi l’aeroporto militare di Castelvetrano, in Sicilia. Di lì venimmo trasportati via aereo a Tripoli, attraversando il cielo del Canale di Sicilia infestato dai caccia britannici.
Una volta raggiunta Tripoli appresi che la mia assegnazione era cambiata, non più il “Romolo Gessi” ma la questura di Derna, una città della Cirenaica a poca distanza dal fronte, ma lì comunque ci rimasi pochi giorni e venni assegnato ad una nuova questura, quella di Misurata, una città sulla costa libica a un paio di centinaia di chilometri dal fronte.
Per raggiungerla dovetti percorrere l’intera via Balbia, la grande arteria stradale che attraversava l’intera costa della Libia, dalla Tunisia ai confini con l’Egitto, incrociando le nostre truppe e quelle dell’Afrika Korps che marciavano in senso opposto, dirette verso il fronte egiziano. Raggiunsi Bengasi insieme ad un convoglio della PAI intorno al 20 settembre 1942 e qui mi trattenni qualche giorno, in una nostra caserma in città. Fu durante questa sosta che gli aerei inglesi bombardarono il porto. Fu un’incursione violentissima, terribile, durante la quale venne colpita una nostra nave carica di munizioni la quale saltò in aria, devastando lo scalo marittimo. Al momento dell’attacco mi trovavo nella nostra caserma di Bengasi, a 4-5 chilometri di distanza dal porto, ma lo spostamento d’aria provocato dall’esplosione fu così violento da causare danni persino all’edificio in cui mi trovavo. Io ed altri agenti venimmo mobilitati per i soccorsi alle vittime dell’attacco. Quando raggiungemmo il porto la scena fu terribile. Decine di corpi di militari e civili, italiani e tedeschi, galleggiavano sulle acque del bacino e tra questi anche due giovani agenti della PAI, uccisi nel corso dell’attacco. Molti erano stati uccisi dal bombardamento ma tanti altri, feriti durante l’incursione erano finiti in mare e, troppo gravi per riuscire a tenersi a galla, erano annegati.
Raggiunsi Misurata pochi giorni dopo e qui iniziò la mia vita da poliziotto.
In quei giorni la questura di Misurata era composta da 25 agenti nazionali tra i quali alcuni poliziotti ausiliari, figli di coloni italiani, e 75 agenti africani, per la maggior parte libici ma anche alcuni ascari eritrei. Ottimi poliziotti, con l’unica ma significativa differenza che, se un agente libico doveva arrestare un criminale italiano doveva “passare” l’incarico ad un agente bianco.
I rapporti tra agenti italiani e indigeni erano molto buoni, anzi amichevoli. Ricordo ad esempio un collega libico che mi invitò a cena a casa sua, insieme ad un altro agente nazionale ed a uno libico. Fu una bella serata, anche se un po’ imbarazzante per me e per l’altro collega italiano poiché, in ossequio alla sua religione, la moglie dell’agente libico rimase sempre in un’altra stanza senza farsi vedere da noi estranei.
Ricordo anche i due sciumbasci eritrei che mi aiutarono molto quando la situazione iniziò a precipitare qualche settimana dopo.
C’erano poi gli altri uffici, da quelli amministrativi a quelli investigativi, come l’ufficio “politico”, organizzato da un giovane ed abile tenente e che aveva il polso della situazione in città.
Anche con i civili italiani ed arabi i rapporti erano buoni, anche se questi ultimi non si vedevano spesso in questura per presentare denuncia per eventuali reati, dato i libici sapevano che se avessimo arrestato i malviventi in base alla loro denuncia, avrebbero rischiato ritorsioni da parte dei familiari degli arrestati.
I miei compiti come poliziotto della PAI erano quelli più istituzionali, come il pattugliamento della città a piedi o in bicicletta, quest’ultimo effettuato solitamente tra Misurata e Misurata Marina, il quartiere costiero della città. Altre volte, quando vi era la necessità di proteggere determinati obiettivi “strategici” ad una certa distanza dalla città, vi venivamo accompagnati a bordo di un camioncino.
Fu un impegno duro, che mi tenne impegnato ogni giorno durante quell’autunno. Misurata era uno dei centri più importanti delle retrovie, sulla via Balbia, la grande arteria stradale che portava i rifornimenti ed i rinforzi al fronte di El Alamein e garantire la sicurezza della città in quei giorni fu un compito gravoso, anche se la questura venne rinforzata con alcuni agenti ausiliari della PAI, per la maggior parte coloni o figli di coloni italiani della regione.
Con i colleghi dell’Arma dei Carabinieri, invece i rapporti erano un po’ difficili, poiché l’Arma era piuttosto gelosa nei nostri confronti.
Anche gli altri reparti della PAI vennero impegnati duramente in quel periodo. A parte il Battaglione Romolo Gessi, al fronte, vi erano gli uomini delle questure di tutta la costa libica che erano duramente impegnati nelle operazioni di vigilanza e sicurezza oppure le decine di portaordini che percorrevano giornalmente la Balbia nei due sensi a bordo delle loro motociclette.
Molti di questi coraggiosi motociclisti dovevano affrontare l’intenso traffico militare della strada, il deserto, gli attacchi dei caccia inglesi e gli inconvenienti della strada, quelli che un europeo non può conoscere in Africa.
Come il collega, del quale purtroppo non rammento il nome, che morì schiantandosi a forte velocità con la propria motocicletta contro un dromedario che gli aveva improvvisamente attraversato la strada nei pressi di Misurata.
Poi arrivò la sconfitta di El Alamein e con essa la ritirata delle truppe italo tedesche, incalzate da quelle britanniche.
Nella seconda metà di dicembre del 1942, con l’incalzare degli inglesi, la situazione si fece estremamente difficile. I predoni provenienti dal deserto iniziarono ad attaccare ed a saccheggiare i villaggi e le abitazioni isolate alle porte di Misurata, rapinando ed uccidendo. Commercianti e semplici cittadini, arabi, turchi ed ebrei, cominciarono ad affollare la questura chiedendo aiuto e protezione.
Era il dicembre del 1942. Io, insieme ad un paio di agenti ausiliari italiani ed alcuni africani, venni incaricato di proteggere i magazzini della sussistenza di Misurata.
I predoni giunsero all’assalto quasi subito. Erano uomini appartenenti alle tribù libiche del deserto, ufficialmente commercianti, ma in pratica saccheggiatori bene armati, spietati e crudeli che si scatenarono su Misurata a colpo sicuro, evidentemente sulla base di buone informazioni.
Ma noi li accogliemmo con gli ottimi mitra MAB della PAI dotati di baionetta ripieghevole, e riuscimmo a respingerli a fatica, dopo lunghe ore di accaniti combattimenti.
Fu l’inizio di una serie di scontri destinata a durare quasi un mese intero.
Gli assalti continuarono anche nei giorni successivi, mentre noi agenti, effettivi, ausiliari ed indigeni, ci battevamo ferocemente contro i predoni con tutto ciò che avevamo.
In un combattimento avvenuto intorno alle 2 di notte, nei pressi della sussistenza, ci trovammo di fronte ad un assalto di predoni arabi. Reagii sparando furiosamente insieme agli altri colleghi sino a che non riuscimmo a respingere i saccheggiatori. Immagino che ne uccidemmo qualcuno, ma il mattino dopo non trovammo alcun corpo a terra, evidentemente portato via durante la notte dai complici.
Un giorno, mentre mi trovavo in questura, giunse una delegazione di civili arabi spaventati che ci segnalò che sul tetto di una piccola costruzione nei pressi della sussistenza era stato trovato uno zaino colmo di bombe a mano abbandonato da qualcuno. Io mi offrii volontario per andarlo a recuperare. Quando arrivai all’edificio salii su un bidone per raggiungere la cima della struttura e scoprii che questo benedetto zaino era pieno zeppo di granate. Con un po’ di incoscienza (tanto che il mio stesso capitano mi diede del pazzo) iniziai a recuperarle una a una ed a passarle ai colleghi che attendevano ai miei piedi.
Non dormii molto in quei giorni e dimagrii di almeno tre chili in quel periodo passato quasi senza mangiare né dormire, poiché dovevamo accorrere da una parte all’altra per reagire ai continui attacchi dei predoni.
Fu il 21 o il 22 dicembre del 1943 che, con le truppe in ritirata dal fronte, giunge anche un generale dell’esercito, accompagnato da un alto ufficiale della PAI.
Il mio comandante mi presentò al generale e disse quale era stato il mio comportamento in quei giorni e il generale parve apprezzare molto “Bravo, guardia Colucci! Se ce la farò ad arrivare a Roma vi proporrò per una promozione o una decorazione al valore!” (la decorazione in effetti arrivò… negli anni ’60. Meglio tardi che mai NDR).
I combattimenti continuarono sino alla metà di gennaio del 1943 quando il nostro comandante ci riunì in questura e ci fece un discorso molto chiaro. Tra di noi c’erano degli agenti sposati e con la famiglia in Italia che non vedevano i loro cari dal giugno 1940, dallo scoppio della guerra. Il comandante voleva sapere se noi giovani poliziotti non sposati eravamo disposti a offrirci volontari al loro posto, per rimanere a Misurata a difendere la popolazione civile. Nessuno si tirò indietro, pur sapendo che avremmo affrontato gli attacchi dei predoni e nel nostro destino ci sarebbe stato il campo di prigionia.
Accettammo, perché era nostro dovere nei confronti dei nostri colleghi più anziani che già avevano combattuto prima di noi.
Quando rimanemmo soli a Misurata eravamo appena una dozzina di nazionali. Degli ausiliari e degli agenti libici non rimase quasi nessuno al nostro fianco.
Furono gli agenti ausiliari italiani a scappare per primi. I poliziotti libici invece rimasero quasi sino all’ultimo, ma almeno loro avevano la giustificazione di avere le loro famiglie da difendere e inoltre correva la voce che le truppe ausiliarie di colore africane in servizio con gli inglesi, avessero l’abitudine di decapitare gli appartenenti alle nostre truppe coloniali. Chi rimase fino all’ultimo giorno al nostro fianco invece furono gli agenti eritrei in servizio in questura come i due sottufficiali, i due sciumbasci, che mi affiancarono in quei terribili momenti. Ne ho parlato più sopra. Furono loro ad aiutarmi a sopravvivere durante i combattimenti di quei giorni. Nonostante il fatto che, in base alle abitudini ed ai regolamenti dell’epoca dovessi essere io, come bianco, il responsabile della pattuglia, mi affidai a loro ed alla loro esperienza, come poteva accadere ad esempio quando, per perlustrare la boscaglia o qualche zona isolata della periferia di Misurata, i due sottufficiali eritrei mi dicevano “Andiamo avanti noi, tu non ti preoccupare” e si inoltravano in avanscoperta mentre io li seguivo mitra in pugno per coprire loro le spalle. Eravamo molto affiatati e rimasero accanto a me sino al giorno dell’arrivo degli inglesi.
Quando le truppe inglesi entrarono a Misurata, il 18 gennaio 1943, noi ritenevamo che ci avrebbero mantenuto in servizio per garantire l’ordine pubblico in città.
Non fu così. Fummo catturati da una compagnia di soldati australiani, ubriachi fradici, i quali ci derubarono di tutto, anche del casco coloniale. Rimediai anche un bel pugno in faccia da un soldato australiano, vai a sapere per quale motivo.
Poi arrivò un capitano inglese, che parlava benissimo la nostra lingua, poiché era stato in Italia prima della guerra il quale prima ordinò di disarmarci e quindi ci interrogò “Lei ha ucciso delle persone in questi giorni?” mi limitai a rispondere di avere sparato, ma di ignorare se avessi ucciso qualcuno. Anche se avevo combattuto per quasi un mese, non ritenni saggio dire la verità.
Il capitano passò quindi alla domanda che evidentemente più gli premeva, cioè dove le truppe italo-tedesche in ritirata avessero nascosto i depositi di armi. Io risposi di non saperne nulla ma in realtà lo sapevo benissimo. I nostri ripiegando avevano occultato un grande deposito di armi a circa sette chilometri da Misurata ed io sapevo dove questo si trovasse, ma non avevo la minima intenzione di rivelarlo. Ero in guerra ed era mio Dovere non dirlo, così risposi negativamente al capitano, il quale e mi disse: “Se lei non rivela dov’è il deposito io la spedisco in Egitto, in campo di concentramento”.
Io giurai per l’ennesima volta di non saperne nulla ma il capitano non mi credette e mantenne la sua parola.
Fu l’inizio della mia prigionia.
LA PRIGIONIA
Quando mi trasportarono in Egitto la mia prima destinazione fu un carcere civile, in mezzo ai detenuti arabi, dei veri bastardi. Sopravvissi per miracolo.
Evidentemente gli inglesi mi volevano fare crollare per indurmi a rivelare dove si trovasse il famoso deposito di munizioni, ma non ci riuscirono e, dopo pochi giorni venni tolto da lì e trasportato al campo criminale 305, nei pressi della cittadina di Ismailia, sul Canale di Suez, dove erano rinchiusi tutti coloro che non volevano collaborare con gli inglesi. I prigionieri erano circa 2000 e venivano non solo dalla Libia ma anche dall’Africa Orientale. C’erano alti ufficiali, esponenti del partito fascista, corrispondenti di guerra e militari come me che avevano rifiutato di cooperare con gli Alleati.
Le condizioni di vita erano dure, già a partire dalla dieta a pane ed acqua usata nei nostri confronti a scopo punitivo quando gli inglesi ritenevano che noi prigionieri fossimo troppo turbolenti, ma anche i maltrattamenti e le sopraffazioni erano all’ordine del giorno. A noi della Polizia dell’Afriuca Italiana gli inglesi ci vedevano come fumo negli occhi a causa dei fascetti che portavamo sul bavero delle uniformi. “Polizia fascista!” ecco quello che eravamo, che fossimo davvero fascisti o meno.
Rammento un episodio grottesco, quando un caporale inglese, dalle note tendenze omosessuali, un giorno entrò nelle docce del campo mentre mi stavo lavando. Il graduato si avvicinò a me ordinandomi di presentarmi immediatamente presso l’ufficio del comando. Mentre perplesso e anche un po’ preoccupato, terminavo in fretta la doccia, chiedendomi il perché di questa improvvisa convocazione e del perché diavolo il caporale non se ne andasse, questi ne approfittò per posare la sua mano proprio “lì”. La mia reazione fu immediata e, senza esitare, sferrai un violento pugno che mandò lungo e disteso sul pavimento delle docce il caporale inglese.
Il risultato furono otto giorni di detenzione in camera di sicurezza, una “scatola” larga un metro e ottanta di larghezza per due metri di altezza, con uno spiraglio piccolissimo da dove entravano poca luce ed aria. Quando mi tirarono fuori di lì, debilitato dal caldo e dagli stenti, quasi incapace di aprire gli occhi dopo tutti quei giorni al buio il caporale inglese mi chiese beffardo “E allora? Ti è passata?”.
Con le poche forze che ancora avevo gli risposi “Ma vaff…!”.
Fu un miracolo se non mi fecero ritornare nella camera di sicurezza.
Come detto le condizioni di vita del capo erano veramente dure. Due prigionieri morirono di malattia e io stesso contrassi la tubercolosi, e non fui certo l’unico.
Per cercare aiuto chiedemmo l’intervento del vescovo cattolico di Alessandria d’Egitto, affinchè intercedesse in nostro favore perché gli inglesi rispettassero il nostro status di prigionieri di guerra e migliorassero le nostre condizioni di vita. Ci aspettavamo molto, ma le nostre attese furono deluse.
Quando il vescovo giunse nel campo 305 ci riunimmo con lui nel piazzale, recitammo insieme le orazioni poi lui ascoltò le nostre lamentele e le nostre richieste d’aiuto quindi salì su un palchetto improvvisato con quattro bidoni vuoti ed un paio di assi e ci disse che aveva ascoltato commosso le nostre parole, ma di essere giunto lì solo per impartirci la sua benedizione….
…come “la benedizione”….?!? Noi crepavamo di fame e maltrattamenti, chiedevamo aiuto e questo signore si limitava ad una benedizione?
Tra noi prigionieri, prima increduli e poi furiosi, ci fu una specie di sollevazione contro il vescovo, che fu costretto a fuggire inseguito dalle nostre grida ed i nostri insulti.
Per avere “trattato male” il prelato l’intero campo venne messo in punizione dagli inglesi, con tre giorni a pane ed acqua, una sofferenza…. però ne era valsa la pena!.
Dopo l’8 settembre 1943 anche noi prigionieri ci dividemmo al nostro interno. Ci fu chi accettò di cooperare con gli inglesi e chi no. Io fui uno di questi ultimi e, anche se nei nostri confronti i maltrattamenti continuarono, non accettai di cambiare idea.
Nel 1946 venni liberato dal campo di prigionia e ad ottobre di quell’anno ritornai in Italia. Durante la detenzione ero dimagrito di molti chili ed avevo contratto la tubercolosi. Quando mia madre mi vide sulla soglia di casa, a Trani, quasi non mi riconobbe. Trascorsi circa un mese dalla mia famiglia.
Durante la mia detenzione la Polizia dell’Africa Italiana era stata sciolta ed il suo personale era confluito nel neonato Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Fu così che poco dopo il mio rientro in Patria venni assegnato alla Questura di Bergamo.
La Polizia di quegli anni era in una situazione a dir poco caotica. Tra gli ex agenti di pubblica sicurezza del periodo prebellico, gli agenti della ex polizia repubblicana della Repubblica Sociale e le guardie ausiliarie delle polizie partigiane la confusione era pressochè totale e i rapporti tra di noi erano a dir poco pessimi.
Ad esempio tra me ed il comandante degli agenti partigiani, un capitano ausiliario che prima della guerra era stato un commerciante di stoffe e che non apprezzava chi, come me, si era battuto al fronte e non si riconosceva nelle divisioni che la guerra aveva portato nel nostro Paese.
Continuai a prestare servizio a Bergamo per circa un anno, sino a quando mi sposai con una ragazza delle mie parti.
All’epoca il regolamento proibiva di sposarsi prima di avere compiuto i 28 anni di età. Quando i miei superiori lo scoprirono mi dissero che se avessi voluto, sarei potuto rimanere ugualmente in Polizia, nascondendo però il mio matrimonio per i quattro anni successivi.
Non accettai, non vedevo il motivo di farlo.
Preferii quindi non sottostare a questa imposizione e questo segnò nel 1947 l’inevitabile fine della mia esperienza nella Polizia dell’Africa Italiana e nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, dopo poco più di un anno dal mio ritorno in Italia.
Da allora mi sono costruito una nuova vita, una famiglia di cui sono fiero, un nuovo lavoro ed oggi vivo la vita tranquilla del pensionato, ma non ho mai dimenticato la PAI, l’Africa, la guerra e tutto ciò che accadde in quei cinque anni tra il 1942 ed il 1947, quando servii l’Italia.
Ne sono fiero, ancora oggi.
Integrazione del 31.12.2013
Con vivo rammarico la Redazione di Polizianellastoria ha appreso dell’avvenuta dipartita della guardia P.A.I. Nicola Colucci avvenuta il 28 dicembre u.s..
Ci uniamo alla Famiglia inviando le più sentite condoglianze.
|
|

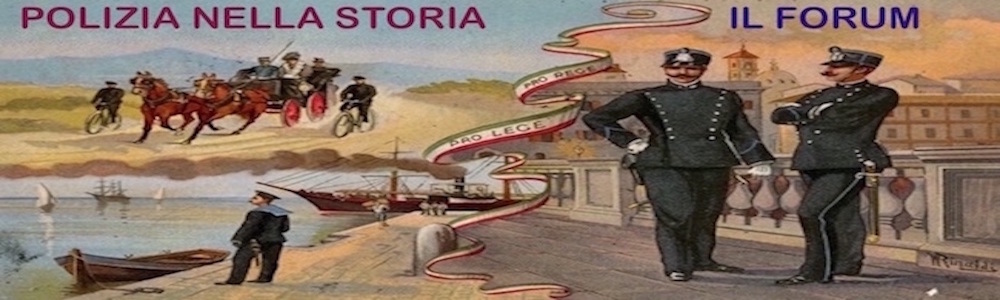




 Anonymous
Anonymous