-
.
I “CARBONARI” DELLA POLIZIA
Trattazione del percorso di smilitarizzazione e sindacalizzazione della Polizia
di Gianmarco Calore
Una tappa fondamentale nella storia della Polizia italiana fu costituita dal lunghissimo percorso che portò alla nascita della Legge di riforma del Corpo (121/81) la quale oggi, a tanti anni dalla sua emanazione, appare come un qualcosa di scontato. Non deve essere così, poiché una tale legge (oltre a costituire un quid unicumevolutivo) affonda le proprie radici in tempi lontanissimi, di estensione ben più ampia del decennio di “lavori” preparatori che ne precedettero la pubblicazione. Alle spalle di tali lavori, centinaia di Colleghi che rischiarono sulla propria pelle tantissimo arrivando a pagare di persona una scelta di democrazia che, in un Corpo militare, era invece considerata attività sediziosa. Questo scritto ha la sola pretesa di ricordare questi Uomini per far capire soprattutto alle giovani “leve” che l’attuale benessere lavorativo in cui sono calati non è qualcosa di dovuto, bensì di guadagnato.
Breve excursus evolutivo della Polizia italiana.
Come già trattato in altra sezione di questo blog, a differenza delle altre Forze di Polizia italiane (le quali mantennero una loro univoca identità sia di denominazione che di inquadramento), la Polizia attraversò almeno 6 cambi di denominazione e 2 cambiamenti di status, da civile a militare e viceversa. Le ragioni sono molteplici: la prima – e forse più importante – fu forse quella che tale Corpo rappresentò più il governo e meno lo Stato, vincolato più di tutti gli altri ai mutamenti di “umore” e di indirizzo politico. Non possiamo quindi parlare di un organismo monolitico (come furono ad esempio l’Arma dei Carabinieri o la Guardia di Finanza), ma di un’entità malleabile, adattabile alla primaria esigenza del mantenimento dell’ordine pubblico, il cui concetto risultò nel corso dei decenni estremamente variabile.
La Pubblica Sicurezza non nacque come articolazione militare. Già lo Statuto carlo-albertino aveva voluto tracciare una strada nuova, che si distaccasse dalle precedenti articolazioni per una maggiore coesione con la cittadinanza. Si poteva parlare di quel concetto che fu poi ripreso dalla 121/81: un’amministrazione civile a ordinamento speciale. La militarizzazione vera e propria ci toccò due volte: la prima nel 1919, con il Corpo della Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza. Il tentativo, male concepito e ancor peggio realizzato, durò poco e finì in modo addirittura tragico. La seconda nel 1943 all’indomani della caduta del Fascismo. Nel timore di un disorientamento degli appartenenti al Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza (civili, ma a inquadramento militare) e ancor più nel timore di una loro mancata esecuzione degli ordini ricevuti, il maresciallo Badoglio con D.L. del 31 luglio 1943 ne militarizzò l’intera struttura, eccezion fatta per quella dei Funzionari di P.S. che mantennero il loro inquadramento civile, gettando il seme per quella creatura “bicefala” che continuò a caratterizzare la P.S. per i successivi 40 anni, ben oltre la fase “emergenziale” per cui era stata concepita. Tale decreto-legge venne poi completato con un nuovo decreto luogotenenziale (il n° 365 del 2 novembre 1944) con il quale, nel ribadire l’inquadramento militare del Corpo, se ne cambiò il nome in quello di Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.
Arrivò poi la Liberazione, la fine della Monarchia, l’entrata in vigore del nuovo ordinamento repubblicano, con una splendida Carta Costituzionale (vero capolavoro giuridico) che avrebbe dovuto mettere al riparo la nuova Italia da qualsiasi rigurgito estremista. In questo ambito ci si sarebbe quindi aspettati un nuovo cambio di direzione anche per la P.S., ma ciò non avvenne. Anzi, con L. 5 maggio 1949 n° 178 il decreto Badoglio del 1943 (che poteva forse avere un senso solo nella fase realmente emergenziale seguita alla caduta di Mussolini) venne definitivamente approvato, incardinando definitivamente la P.S. in ambito militare, con tutte le derive del caso.
Vale la pena di soffermarsi brevemente su quest’ultimo passaggio, da taluni osservatori dell’epoca definito proditorio. La conversione in legge del decreto-Badoglio non costituì discussione a sé stante (come ci si sarebbe dovuti aspettare) ma rientrò in una serie di modifiche eterogenee a molti ambiti dell’intera pubblica amministrazione ereditati dal periodo bellico. Dai lavori parlamentari emerge un dato di fatto che, a parere di chi scrive, può essere considerato il primo passo falso: ben pochi politici accamparono proteste per questa ribadita militarizzazione della Polizia, tantopiù che vennero ignorati perfino i pareri molto più lungimiranti della Allied Commission che aveva posto in evidenza molte gravi storture organizzative peculiari sia all’organizzazione militare in quanto tale, sia all’organizzazione gestionale e addestrativa dei singoli uomini. I primi timidi progetti di rinnovamento (veniva portato come esempio dagli Alleati il modello del policeman, inteso come poliziotto di quartiere) vennero inspiegabilmente ignorati sia da De Gasperi che da Parri che, nel recepire in modo integrale il decreto-Badoglio del 1943, si limitarono invece a ribadire
«[l’]appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza [sic] alle Forze armate dello Stato e applicazione della legge penale militare ai componenti il Corpo stesso».
Il primo evidente riflesso sulla vita pratica dell’agente di Polizia fu la sua considerazione professionale parificata in tutto e per tutto a quella di un soldato. La cosa non riveste scarsa importanza, solo a voler considerare che un soldato è chiamato al disimpegno di compiti e funzioni completamente diverse da quelle richieste a un Poliziotto. La pedissequa applicazione di un regolamento militare annullò quella capacità decisionale richiesta a un operatore di Polizia a seconda del grado rivestito, “schiavizzandone” il ruolo e appiattendone la mansione. L’agente di Polizia doveva essere quindi ridotto a un mero esecutore di ordini, senza alcuna possibilità di riflessione sulla loro eventuale illegittimità, creando così un Corpo inteso come braccio armato del governo.
L’aspetto rigorosamente militare del Corpo predilesse una formazione degli allievi che ne rispecchiasse l’inquadramento: qui siamo a Caserta nel 1945
Da alcuni storici si cercò di trovare una spiegazione plausibile nella ribadita militarizzazione della P.S. facendo leva sia sul profondo malessere sociale (che si rifletteva in scioperi e manifestazioni di piazza anche molto violente), sia sul timore di uno sbandamento del Paese a sinistra. Quest’ultimo aspetto fu ampiamente confermato anche dalle epurazioni del personale che fin dal 1947 colpirono il Corpo: se nell’immediato dopoguerra il governo provvisorio aveva preferito far transitare tanto nel Corpo delle Guardie di P.S. (articolazione militare), quanto nell’Amministrazione della P.S. (articolazione civile) gli appartenenti alle formazioni resistenziali, con l’arrivo di Mario Scelba al ministero degli Interni si assistette a un repentino cambio di direzione nel senso diametralmente opposto, con l’allontanamento del personale così assunto e la reintegrazione di personaggi più o meno palesemente compromessi con la precedente forma di governo. E questo a tutti i livelli. Di tali epurazioni lo stesso Scelba non fece mai mistero, confermandone la necessità in interviste ufficiali rilasciate anche a molti anni di distanza: la guardia, il sottufficiale, l’ufficiale o il funzionario le cui note caratteristiche lo collocavano in ambito appena più a sinistra della corrente democratica dorotea veniva con linguaggio moderno sottoposto a vero e proprio mobbing, dapprima blandito con offerte economiche di buonuscita in caso di suo volontario proscioglimento, e poi con trasferimenti in sedi lontane e disagiate, sottoposto a continue vessazioni e accanimenti disciplinari il cui risultato, nella stragrande maggioranza dei casi, era comunque il proscioglimento.
Quanti furono questi epurati? Dall’archivio del Ministero dell’Interno non emergono dati ufficiali, sia perchè il fenomeno veniva appositamente sottaciuto, sia perchè lo stesso fu comunque diluito nel tempo: solo Scelba, messo alle strette, affermò che il numero di poliziotti così allontanati si aggirò sulle 7-8.000 unità.
Significato di una Polizia a ordinamento militare
Dalle premesse sopra delineate discesero “a cascata” conseguenze tra le più eterogenee, la cui gravità colpì il Corpo della P.S. in vari momenti, sia nell’immediatezza che nella media e lunga distanza. Per capirne meglio la reale portata si deve effettuare un’analisi temporale, poiché se da un lato il Ministero volle negare l’accrescimento del bagaglio culturale del singolo agente, dall’altro quest’ultimo iniziò a procedere a passi sempre più spediti, con l’acquisto via via più rapido di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e della propria funzione.
Genova Bolzaneto, 1950: un gruppo di guardie aggiunte al rientro dalla libera uscita
Il primo lasso temporale riguarda dunque il periodo che va dal 1946 ad almeno il 1960. Soprattutto nella prima fase, basta dare un’occhiata ai criteri di arruolamento per capire come si guardasse più ai numeri che alla qualità, più alla forma che alla sostanza. La maggior parte degli allievi proveniva da zone depresse della nazione, con un grado di analfabetismo che in molti casi impediva loro di scrivere correttamente anche solo il proprio nome. Il percorso formativo era di conseguenza lacunoso e incompleto: da un lato si prediligeva la formazione militare, di inquadramento e assetto formale a tutto discapito della formazione culturale e professionale; dall’altro si esercitava lo strumento della disciplina in modo assolutamente arbitrario, come sorta di “spauracchio” per ogni azione fatta o non fatta dall’allievo. Questo aspetto ne porta alla luce un altro, immediatamente consequenziale: quello della catena di comando costituita da ufficiali provenienti dall’Esercito, con una formazione specifica magari ottima, ma assolutamente privi della professionalità e specifica preparazione richieste a un Poliziotto. Il materiale iconografico dell’epoca ci trasmette infatti allievi guardie spesso malvestiti e ancor peggio presentabili, tuttavia costretti a continue ed estenuanti marce, presentat-arm, inquadramenti, servizi di guardia al pari di un qualsiasi fante. Solo dalla metà degli anni Cinquanta cominciano a circolare fotografie di allievi finalmente seduti in un’aula e con un libro in mano. Ma anche in questo caso, proprio per gli inesistenti criteri di arruolamento, non si trattava di formazione tecnico-professionale specifica e connaturata alle mansioni che i nuovi poliziotti sarebbero andati a esercitare, bensì di formazione di base: grammatica italiana, rudimenti di matematica, nozioni elementari di storia e geografia. Come ebbe a dire un ufficiale di quel periodo, “si doveva prima far sì che in caserma tutti parlassero la stessa lingua”.
Roma, 1947: sotto l’aspetto formale l’eterogeneità delle uniformi rispecchia la sostanziale situazione di arretratezza dell’immediato dopoguerra.
Il ministero, resosi conto della problematica, a partire dal 1955 introdusse criteri più stringenti per l’accesso ai ruoli: alla necessaria sana e robusta costituzione accompagnata dal godimento dei diritti civili e politici inizialmente richiesti come unici requisiti seguirono l’introduzione di un titolo di studio minimo, di un preliminare accertamento culturale e di più specifici esami sanitari e psicologici, questi ultimi grazie alla costituzione a Roma della prima struttura medico-legale deputata alla valutazione dei requisiti psicoattitudinali del candidato. Ma anche questa innovazione, sebbene in grado di operare un “filtro” abbastanza importante rispetto al recente passato, venne criticata dagli stessi “addetti ai lavori” a causa soprattutto della superficialità e ripetitività dei test somministrati ai candidati.
Il secondo lasso temporale può invece circoscriversi dal 1960 ad almeno il 1973. Durante esso, grazie alle figure lungimiranti e innovative del prefetto Vicari e dell’onorevole Fanfani, furono introdotte significative migliorie nella qualità media della vita di un operatore di Polizia. All’onorevole Fanfani va il merito di avere introdotto l’istituto del riposo settimanale obbligatorio (prima inesistente) mentre al prefetto Vicari (nel ruolo di Capo della Polizia) va il merito della predisposizione di tutta una serie di provvedimenti per il rilancio dell’immagine della Polizia che doveva essere “al servizio del Cittadino”: tali provvedimenti riguardarono innanzitutto il miglioramento della qualità degli alloggi di servizio, della salubrità dei luoghi di lavoro, della mensa obbligatoria cui il personale per regolamento di servizio era tenuto a servirsi; vennero introdotti nuovi modelli di formazione dell’allievo grazie all’implementazione delle scuole di Polizia che passarono da 9 a 20, con nuovi programmi che misero in primo piano il ruolo professionale rispetto a quello di inquadramento militare, dando la possibilità all’allievo di frequentare ulteriori corsi per il conseguimento della licenza elementare (in questo caso, la durata del corso di formazione di base della durata di 6 mesi veniva ampliato a un anno); anche l’assetto operativo cambiò radicalmente grazie ad articolati provvedimenti di rinnovamento del parco auto, delle armi in dotazione, degli strumenti tecnici di indagine; venne creata finalmente l’Accademia Ufficiali del Corpo delle Guardie di P.S., svincolandone così la nomina dai ruoli dell’Esercito e forgiando futuri comandanti che erano per prima cosa poliziotti; le comunicazioni radiotelefoniche dal centro agli uffici periferici e da questi ultimi alle pattuglie sul territorio furono totalmente rinnovate grazie alle più recenti innovazioni tecnologiche, la cui punta di diamante fu la nascita del 113, il numero unico delle emergenze attivo gratuitamente dal 1° marzo 1968 su tutto il territorio nazionale; presso il ministero venne creata la Divisione di Polizia Criminale con funzioni di coordinamento interforze e di centralizzazione delle informazioni provenienti dai vari uffici di Polizia.
Caserta, 1964
Insomma, da un esame abbastanza rapido si potrebbe sostenere di avere avuto di fronte finalmente quell’homo novus da tanto atteso per una radicale riforma della Pubblica Sicurezza: in realtà non fu così. Sia Fanfani che Vicari, pur nella loro meritoria opera di rinnovamento, attesero a quest’ultimo in un’ottica di maggiore funzionalità dell’apparato da loro diretto e gestito e non certo in un’ottica di accoglimento delle rimostranze che continuavano a pervenire dagli operatori di Polizia in quantità sempre più massicce ancorchè anonime, per timore di ritorsioni. Sotto questo aspetto infatti, la figura del singolo agente continuava a restare fortemente incardinata nell’ordinamento militare, senza alcuna innovazione nemmeno sotto l’aspetto del regolamento di disciplina che ne limitava fortemente l’esplicazione delle proprie problematiche; lo stesso riposo settimanale, previsto sulla carta, continuava a venire troppo spesso negato a causa delle preminenti (e spesso inesistenti) “necessità di servizio”, tanto da costringere il ministero a richiamare più volte i questori sul rispetto di questo diritto: tuttavia ancora nel 1975 soprattutto nei Reparti Mobili e Celeri il riposo settimanale continuava a restare una chimera.
Il terzo lasso temporale andò infine dal 1974 al 1981 e fu costituito da una fase tra le più effervescenti che portò alla legittimazione dei comitati clandestini di poliziotti democratici e alla smilitarizzazione e sindacalizzazione del Corpo. Questo periodo merita dunque una trattazione a parte che faremo tra breve.
Le origini del malessere
Per meglio comprendere il percorso che ha portato al concepimento della 121/81 e al suo lungo percorso “gestazionale” vanno descritte le condizioni umane e professionali in cui si dibatteva una guardia di pubblica sicurezza. E per farlo, dobbiamo tornare di nuovo agli albori della Repubblica, con governi fragili e tanta, troppa incertezza.
Del repentino mutamento dei criteri di arruolamento definito con il termine di “epurazione” abbiamo già accennato. L’emergenza dettata dalla necessità di ricostituzione di un Corpo di Polizia in tempi rapidissimi per far fronte soprattutto ai numerosi moti di piazza indusse il ministero a concepire una figura professionale tra le più contorte e discutibili, ma forse – va detto – l’unica in grado di rispondere al meglio a questo tipo di emergenza: la figura dell’ “aggiunto”. Si trattava di un poliziotto (prevalentemente guardie, ma abbiamo testimonianza anche di sottufficiali, ufficiali e funzionari) a ferma prefissata, una sorta di “precario della Polizia” che si dibatteva di rafferma in rafferma nella speranza di essere ammesso al corso per effettivo. Al suo inquadramento militare (con tutte le limitazioni collegate), su di lui pendeva l’ulteriore “spada di Damocle” del proscioglimento al termine della ferma contratta e una limitazione negli impieghi operativi che lo vedevano ristretto ai servizi di ordine pubblico oltre che a quelli di bassa manovalanza da casermaggio. La sua eventuale ammissione al corso per effettivo era inoltre subordinata a valutazioni dei propri superiori gerarchici, molto spesso assolutamente soggettive e legate più agli aspetti “umorali” di questi ultimi che non a criteri di obiettività. La figura dell’aggiunto, che nei ruoli di sottufficiale, ufficiale e funzionario sparì progressivamente nella prima metà degli anni Cinquanta, continuò invece a perdurare per le guardie di P.S. fino al 1961, anno in cui, grazie a una parziale modifica del regolamento del Corpo, sparì definitivamente.
Proprio il terreno insidioso dell’ordine pubblico fu il palcoscenico principale in cui andò in onda tutto il pressappochismo gestionale e tutta l’arretratezza che caratterizzava la P.S. negli anni Quaranta e Cinquanta. Il personale dei Reparti Mobili e Celeri (nuove “creature” volute dal ministro Scelba), tenuto artatamente all’oscuro di quanto sarebbe andato a fronteggiare, usciva di contro dalle caserme armato ed equipaggiato con armi lunghe e armamento pesante, visto che le dotazioni prevedevano l’impiego di mitragliatrici pesanti, di autoblinde e addirittura di carri armati leggeri. Il sistema di contrasto dei manifestanti in uno scenario di pace, così come certificato da un ufficiale del Corpo (l’allora maggiore Giovan Battista Arista) non si discostava in nulla dal contrasto di formazioni militari o paramilitari in uno scenario bellico: i risultati purtroppo non si fecero attendere e fin da subito l’impiego delle armi da fuoco nelle manifestazioni di piazza provocò decine di morti tra i dimostranti: nel periodo 1948-1960 si contarono 6 morti tra le Forze di Polizia e ben 90 tra i manifestanti, così come riportato da D’Orsi nella sua opera “Il potere repressivo”.
1946, Milano. I Reparti Mobili di Polizia schierati con armamento pesante
Sul piano del controllo del territorio le cose cambiavano di poco. A un contrasto scientifico e capillare della criminalità (fortunatamente ancora in fase embrionale e pertanto non organizzata, bensì “da sopravvivenza”) facevano da contraltare i cosiddetti “pattuglioni”, che assomigliavano più a dimostrazioni “muscolari” di forza che miravano a far sentire il cittadino costantemente controllato e sotto assedio che non volti a trasmettergli reale sensazione di sicurezza. Questo aspetto veniva addirittura autocelebrato alla fine degli anni Quaranta nei vari telex trasmessi dalle Prefetture al ministero, nei quali si sottolineava la “vivissima impressione” suscitata dalle parate militari, la “sensazione di ordine e potenza trasmessa dai reparti corazzati” quasi che la preoccupazione maggiore fosse quella di incutere timore soprattutto in determinate aree di appartenenza politica del tessuto sociale. Sempre su questa linea si insinuarono i questori che non esitarono a chiedere il potenziamento dell’organico a loro disposizione, meglio se “dotato di autoblindo e carri armati” poiché “solo così si terranno a bada i troppi facinorosi di sinistra e si darà sicura tranquillità per le elezioni”. E ancora: “Il marziale aspetto di questi [reparti], l’ordine impeccabile con il quale hanno sfilato, il grandioso spettacolo di forza e di sicurezza e dalle qualità di mezzi attualmente in dotazione alla polizia, hanno vivamente impressionato gli spettatori”.
1948, “blocchi volanti” della Polizia
E proprio la politica, vissuta in modo viscerale, costituì un ulteriore elemento detonante in una già precaria situazione sia all’interno che all’esterno delle caserme di Polizia. Poichè se è vero che il cittadino comune era sottoposto a continui e asfissianti controlli che tenevano conto di ogni sua affermazione che poteva in qualche modo collocarlo in una determinata sfera (le cui informazioni confluivano in uno speciale schedario centrale chiamato Schedario politico, abolito solo alla fine degli anni Sessanta), lo stesso militare di P.S. vedeva i suoi diritti ulteriormente compressi: numerose circolari vietavano la lettura di determinati quotidiani e riviste, ritenuti non “politicamente corretti”, impedivano l’adesione a qualsiasi circolo, associazione o comitato indipendentemente dalla loro natura e vietavano discussioni di carattere politico all’interno delle caserme. Il tutto sotto la costante mannaia del regolamento di disciplina, la cui estrazione militarmente estremizzata consentiva un esercizio soggettivo ed arbitrario senza possibilità di replica da parte di chi vi era sottoposto.
Si badi che le sanzioni previste dal regolamento di disciplina prevedevano sanzioni di vera e propria custodia cautelare che spaziavano dalla cella penale di rigore alla cella penale semplice, dalla camera di punizione alla consegna in caserma, oltre naturalmente ad altre sanzioni quali la destituzione, la sospensione dal servizio, la pena pecuniaria.
Ne consegue che la singola figura del militare di P.S. era eternamente schiacciata da tre grossi macigni: il regolamento di disciplina (applicato come detto molto spesso in modo soggettivo e arbitrario), il codice penale militare di pace (che prevedeva reati tipicamente militari di competenza del relativo tribunale) e la magistratura ordinaria (pertinente per la rimanente tipologia di reati di natura civile). Se vogliamo soffermarci ad esempio sul reato di “violata consegna”, la cui fattispecie prevedeva una qualsiasi disattesa di un ordine formulato per iscritto, ben si comprende la vacuità del concetto di “disattesa” che poteva essere ravvisata anche in un ordine eseguito sì, ma non come il soggetto ordinante aveva inteso.
Un’ulteriore compressione dei più elementari diritti civili non solo di qualunque cittadino, ma anche di qualunque impiegato dello Stato impediva al militare di P.S. il matrimonio non solo per tutta la durata della ferma da “aggiunto” (e quindi fino al raggiungimento della qualifica di effettivo), ma almeno fino al compimento dell’ottavo anno di servizio e comunque non prima del compimento del 30° anno (ridotto a 28 nel 1966 e a 26 nel 1973). Rispettati questi requisiti, il militare avrebbe comunque dovuto inoltrare domanda formale al ministero il quale aveva l’obbligo di valutare la moralità della sposa e dei parenti di lei, potendo negare l’autorizzazione in caso di qualsiasi problema emerso in istruttoria. L’agognata autorizzazione aveva poi valore di soli tre mesi, scaduti i quali sarebbe decaduta obbligando il militare a ricominciare daccapo tutta la trafila. Solo con il matrimonio inoltre il militare poteva essere autorizzato a non risiedere in caserma. Un’eventuale convivenza di fatto (e vieppiù l’arrivo di figli illegittimi) comportava inoltre l’immediato licenziamento.
Il matrimonio di una guardia di P.S. era il coronamento di un iter professionale e burocratico estremamente tortuoso
Ma il quadro già di per sé deprimente non è ancora completo. Anche l’aspetto economico incideva negativamente sulla qualità della vita della guardia di P.S.: alla paga assolutamente bassa veniva detratta una percentuale come contributo alle spese di casermaggio senza che facesse da contraltare alcuna indennità aggiuntiva. Nessun riconoscimento del lavoro straordinario, nessuna indennità per i servizi notturni, festivi, di ordine pubblico, ma orari di servizio assolutamente massacranti e improvvisi obblighi di permanenza in caserma anche per il personale ammogliato, in ottemperanza a non meglio specificate “improvvise” esigenze di servizio. E ancora la qualità delle infrastrutture portò alla luce in modo drammatico numerosi casi di malattie, da quelle gastrointestinali dovute al rancio qualitativamente quasi ovunque ben al di sotto del minimo per poterlo considerare cibo, a quelle polmonari (con recrudescenza della tubercolosi) a causa degli ambienti insalubri, con decine di militari ammassati in stanzoni sudici, freddi d’inverno e caldissimi d’estate e con servizi igienici fatiscenti.
Le condizioni di promiscuità spesso insalubri della vita di caserma favorirono lo sviluppo di malattie e problemi igienico-sanitari
Un altro anacronismo che emerge dalle pieghe del regolamento del Corpo riguardava gli adempimenti degli obblighi di leva che l’arruolamento in Polizia NON sostituiva. Ne conseguiva che il militare che non si vedesse prorogata la ferma avrebbe dovuto adempiere al servizio militare come un qualsiasi altro “najone”. Questa assurdità fu finalmente eliminata negli anni Sessanta quando il servizio reso nel Corpo delle Guardie di P.S. divenne finalmente comprensivo degli adempimenti della leva.
Inoltre, secondo una logica militare di stampo squisitamente borbonico, molte guardie e sottufficiali di P.S. vennero distolti dal loro peculiare servizio per essere posti alle dirette dipendenze di questori, comandanti e prefetti in qualità di attendenti, domestici, camerieri, scrivani, autisti, giardinieri. Questo malvezzo, criticato aspramente da più parti, pur se stigmatizzato anche dal ministero proseguì addirittura fino alle soglie della smilitarizzazione del 1981, nonostante le recrudescenze del terrorismo eversivo avessero costretto la Polizia a recuperare quanti più uomini possibili da destinare ai servizi operativi di controllo del territorio e di prevenzione generale. La figura di questi “non-poliziotti” fece coniare a loro carico il termine dispregiativo di “sciacquini” che contribuì ancora di più a svilire la loro persona e la loro mansione. Dalle circolari ministeriali consultate sembra che tale fenomeno, assunto agli onori della cronaca a più riprese e diventato uno dei “cavalli di battaglia” dei comitati per la smilitarizzazione, avesse assunto dimensioni preoccupanti poiché, sebbene non codificato da alcuna norma del regolamento del Corpo, basò le sue fondamenta sulla fonte non scritta più dannosa: quella della consuetudine. A parere di chi scrive tuttavia un tale fenomeno non deve essere letto a senso unico, solamente come un ennesimo abuso: fonti testimoniali dirette hanno confermato che la mansione di “sciacquino” andava comunque bene a molti operatori di Polizia (che oggi definiremmo “imboscati”) che non solo sfruttarono questo servizio per sottrarsi ai ben più pericolosi servizi di strada, ma anche trassero benefici personali grazie al rapporto diretto con le alte autorità cui erano alle dipendenze. A questo riguardo, almeno cinque ex appartenenti al Corpo (che hanno chiesto garanzia di anonimato) sono stati concordi nel confermare che grazie al servizio da cameriere presso il prefetto X molti ottennero l’assunzione di figli e parenti nelle amministrazioni statali oppure che grazie al compito di attendente del colonnello Y si ottennero celeri trasferimenti a domanda o altri benefici di natura personale, in un perverso gioco del do ut des.
Ma allora perchè entrare a far parte di un organismo così tanto compresso? Sicuramente la povertà diffusa, soprattutto al centro-sud del Paese, costrinse molti poliziotti a cercare l’unica via d’uscita per garantire a se stessi e ai propri familiari una vita più decente. Non dimentichiamo che l’Italia manteneva un elevatissimo numero di zone definite “depresse”, in cui la sola fonte di sostentamento era quel poco che veniva garantito dai campi e dal poco bestiame. Pochissime le città industrializzate, concentrate prevalentemente al nord e comunque vistosamente sinistrate dalla guerra appena conclusa. Una simile situazione, che caratterizzò il nostro Paese fino almeno alla metà degli anni Cinquanta, creò le condizioni ideali anche per l’arruolamento nel Corpo anche se, soprattutto dal 1955, si assistette a un’onda in senso contrario, con numerosi proscioglimenti volontari.
La domanda che sorge dunque spontanea – e che forse costituisce il primo punto di questa analisi – è dunque questa: da quando iniziarono i primi fenomeni di malumore all’interno del Corpo? Un’analisi superficiale porterebbe a ritenere i primi dissensi come il frutto di un periodo abbastanza lungo di maturazione e di acquisizione della consapevolezza delle proprie mansioni. In realtà, a leggere la data delle prime manifestazioni formali di dissenso, c’è da rimanere sconcertati.
Fu il 1947.
In un’Italia ancora priva di una carta costituzionale e con una repubblica che aveva emesso i suoi primi vagiti, un gruppo di poliziotti che si definirono “democratici” mise nero su bianco non solo una sterile ancorchè comprensibile lamentela, ma addirittura una linea programmatica di cui alcuni punti saranno ripresi proprio dalla 121/81 quasi quarant’anni dopo. Questi primi fenomeni di rigurgito dovettero preoccupare il ministero il quale da un lato predispose una fascicolatura riservata intitolata proprio “Fenomeni di malessere del personale”, dall’altro dette disposizioni molto severe affinchè i latori delle prime missive anonime inviate non solo ai giornali, ma addirittura allo stesso Capo della Polizia, venissero celermente individuati ed altrettanto esemplarmente puniti. Leggiamo assieme questi punti programmatici così come estrapolati dalla documentazione originale:
1 – Dare al corpo un completo assetto civile togliendolo dalla situazione confusa in cui si trova.
2 – Le forze di PS chiedono di costituirsi in sindacato di categoria perché siano riconosciuti loro i diritti morali, materiali ed economici.
3 – Promulgare un regolamento organico del corpo aggiornato e veramente democratico che sia mezzo efficace per reprimere ogni malcostume e corruzione. Commissioni democraticamente elette debbono affiancare le azioni del comando tendente al miglioramento delle condizioni di assistenza, di igiene e della cultura degli agenti18.
4 – Gli agenti di polizia debbono essere considerati impiegati di concetto (gruppo C) categoria X; ad essi verrà corrisposta una indennità di servizio adeguata al lavoro notturno e diurno al quale sono chiamati a svolgere.
5 – Dare a tutti gli agenti al compimento del 6° anno di servizio di accedere al grado superiore senza limiti di età e pregiudizio del titolo di studio, tenendo conto che al grado superiore possono aspirare il 50 per cento per anzianità e il 50 per cento per titolo acquisito.
6 – L’agente di polizia non deve essere mai adibito a mansioni di servilismo ma deve espletare il proprio dovere per cui è stato arruolato, poiché tale servilismo non onora ma disonora gli stessi superiori che lo obbligano a tali mansioni screditando tutto il corpo davanti ai cittadini.
7 – L’agente deve essere arruolato a vent’anni d’età e, compiuti i 30 anni di servizio e raggiunta l’età di 50 anni, dovrà essere collocato a riposo. Sei mesi prima del collocamento a riposo debbono essere espletate le pratiche per la pensione, al fine di evitare che l’agente si trovi per circa un anno senza possibilità di vivere come accade nell’attuale ordinamento.
8 – Migliorare il trattamento economico, indennità di presenza, di trasferta o di alloggio in modo di adeguarlo all’attuale costo della vita. Tenere presente in questi miglioramenti che il servizio è quanto mai gravoso, spesso senza limiti di orario e riposo settimanale.
9 – Adibire al servizio sedentario gli agenti mutilati di guerra. Mutilati in servizio e a causa del servizio, sempreché gli agenti mutilati siano collocabili.
10 – Abbassare il limite di età dai 28 ai 25 anni per il matrimonio e fornire ad ognuno la possibilità di mantenere dignitosamente la propria famiglia, aumentando gli assegni familiari.
11 – Estendere effettivamente agli agenti il beneficio delle case popolari dell’INCIS.
12 – Tenere conto per quanto possibile delle richieste di destinazione per stabilire il proprio avvicinamento a casa dopo tre anni di servizio.
13 – Organizzare l’assistenza sanitaria in modo efficiente sia agli agenti che alle loro famiglie, mantenere durante il periodo di degenza e di convalescenza gli assegni tutti e non solo l’indennità di presenza anche quando la malattia non dipende da causa di servizio.
14 – All’agente di polizia civile che durante il servizio commette mancanze disciplinari non si debbono infliggere punizioni umilianti rinchiudendolo in camera di punizione ma va punito con punti di demerito o con una percentuale ritenuta sulla busta paga.
Ora, a leggere queste righe e a non conoscere la data della loro estensione c’è da rimanere quantomeno allibiti di fronte alla chiarezza di idee che già in quell’anno era maturata tra il personale. Emerge un dato incontrovertibile: a soli 4 anni dalla nuova militarizzazione voluta da Badoglio, il clima all’interno del Corpo era già diventato insostenibile.
La risposta del ministero
Un simile fenomeno, che esorbitava dal ben più blando e tollerato “mugugno” professionale, caratteristica di tutta la pubblica amministrazione, destò subito forti preoccupazioni ai vertici della P.S. che subito corse ai ripari ordinando una capillare attività di monitoraggio interna accompagnata dalla massima severità nei conseguenti provvedimenti.
Il periodico “Rivista di Polizia”, destinato a funzionari e ufficiali, portò inoltre alla ribalta un’aspra polemica tra i primi e i secondi sui rispettivi trattamenti economici, di progressione di carriera, di agevolazioni e sulle frizioni tra le rispettive linee di comando.
Le questure vennero letteralmente subissate di telegrammi e circolari che avevano il preciso scopo di costituire una sorta di “schedatura” interna del personale, attuata molto spesso sulla base di semplici sospetti. La vita professionale e personale di migliaia di guardie, sottufficiali e più raramente di ufficiali e funzionari fu passata sotto l’attenta lente di ingrandimento dei rispettivi superiori gerarchici alla ricerca molto spesso anche di un semplice pretesto per adottare provvedimenti di isolamento, trasferimento o addirittura di licenziamento. Dall’esame di questa attività di “polizia nella polizia” non si deve tuttavia leggere un sistema di indagine a senso unico: in alcuni casi emersero in effetti episodi che, al di là dell’aspetto penale, potevano costituire tentativi di infiltrazione di frange politiche estremiste all’interno del Corpo. Fu il caso ad esempio di due sottufficiali della Polizia Stradale di Ancona, trovati in possesso di armi non regolamentari custodite nella camerata da essi occupata: l’indagine era partita sulle riferite affermazioni pronunciate da uno dei due e che lo collocavano apertamente a sinistra. La vicenda si concluse con il licenziamento del sottufficiale risultato maggiormente compromesso e con il trasferimento d’ufficio del secondo.
Dall’archivio del ministero emergono decine di altri fatti, più o meno gravi, ma i cui provvedimenti finali erano sempre draconiani. Due guardie del Gruppo Guardie P.S. di Terni vennero sorprese con alcuni volantini del Partito Comunista e una tessera del medesimo partito; ad Avellino un militare fu visto partecipare in divisa a un comizio, esprimendo solidarietà per quella frangia politica (sempre di sinistra); a Milano, molti militari subirono lo stesso trattamento anche solo per sospetto di attività filocomunista, con trasferimenti all’altro capo della Penisola.
Stessa sorte anche per alcuni funzionari di P.S.: il questore di Cosenza venne trasferito d’ufficio con nota di biasimo solo perchè non aveva vigilato accuratamente sui criteri di rilascio dei passaporti. In specie, a un noto esponente del P.C.I. locale venne ugualmente rilasciato il documento di espatrio che – a quanto pare – gli servì per passare “oltre cortina” raggiungendo la Cecoslovacchia. A Napoli un commissario venne sollevato dal servizio poiché ancora iscritto all’A.N.P.I. dopo il suo ingresso in amministrazione.
Se in genere non si transigeva nei confronti di guardie e sottufficiali, manica un po’ più larga veniva usata con i funzionari, forse perchè più facilmente controllabili o addirittura per uno spirito corporativistico che sembrava permeare la gestione della P.S. in quegli anni. Tuttavia il clima di delazioni, sospetti, inchieste interne esasperarono ulteriormente il clima facendo sì che la medicina fosse peggiore del male. Agli atti del ministero risultano infatti – e sono la maggior parte – inchieste interne finite con l’archiviazione per infondatezza dei sospetti poiché basate su delazioni spesso anonime che provenivano in taluni casi da colleghi dell’indagato, bramosi di toglierlo di torno unicamente per le proprie ambizioni personali di carriera.
Se questo sistema di strettissima vigilanza interna si era ben sviluppato nel corso di tutti gli anni Cinquanta, esso parve raggiungere il proprio apice tra il 1958 e il 1960 col governo Tambroni, quando il numero di trasferimenti d’ufficio e licenziamenti arrivò a cifre impressionanti.
D’altro canto – tornando alla logistica del Corpo – proprio le ispezioni predisposte dagli Ispettorati di Zona confermarono in moltissimi casi le condizioni precarie delle strutture e degli uomini, la maggior parte dei quali apparivano nettamente sottopeso, affetti da malattie cutanee e con una forte recrudescenza di tubercolosi che costringevano i malati a lunghi ricoveri negli ospedali militari o nei sanatori, con esiti alcune volte purtroppo letali.
In ogni caso l’intervento del ministero in chiave repressiva sortì l’effetto contrario. Il sistema di contatto (rigorosamente in forma anonima) tra le guardie di P.S. e gli ambienti giornalistici maggiormente sensibili al problema da loro rappresentato si fece ancora più stringente, forte del fatto che davvero pochissimi militari vennero effettivamente collegati a queste missive. Il germe del malumore piantato nel 1947 parve dunque attecchire durante tutti gli anni Cinquanta e a svilupparsi nel decennio successivo, tanto da costringere nel maggio 1968 la neonata rivista ufficiale del Corpo (“Polizia Moderna”) a stigmatizzare ancorchè in modo edulcorato queste proteste, facendo leva sul buon nome della Polizia e sul fatto che la catena di comando si era sempre dimostrata aperta alle critiche costruttive (sic!) provenienti dai suoi subordinati. Vale la pena di leggere questo articolo che, sotto la facciata bonaria, nasconde tra le righe ben altro atteggiamento:
Le anonime che qualche volta circolano tra noi denunciano quasi sempre manchevolezze reali, avanzano proposte intelligenti, esprimono proteste che, se fossero firmate, sarebbero bene accette. Quelle lettere, firmate, offrirebbero agli organi superiori, che naturalmente non possono tutto vedere e tutto prevedere, una collaborazione preziosa per il miglior andamento della nostra famiglia e del servizio, ma così, senza faccia, senza firma, quelle lettere finiscono nel cestino perché chi le riceve è portato istintivamente a distoglierne lo sguardo, a ritirare le mani come se stesse per sporcarsi. E poi le prende con due dita, come cose immonde, e le butta via. Da noi si sa che chi scrive è una bravissima persona […]. Non è certamente un vile, la sua faccia onesta e aperta non è quella dello scrittore abituale di anonime. […] Ma allora perché non firma? Per timore della «grana»? Eh via! Il militare ha sempre la possibilità di mettersi in contatto con i superiori che sono lì per ascoltare, per giudicare, per rimediare; con i superiori che desiderano essere informati. […] Perché mai uomini abituati alla lealtà, abituati a pagare di persona […] debbono passare, a torto, per vecchiette pettegole e maligne? Cancelliamo questo grosso equivoco perbacco! A faccia alta, posizione corretta, nella posizione dell’«attenti» che non è certamente servile ma è raffigurazione del virile coraggio morale, si dica ciò che a proprio giudizio non va. Se ne riceverà una lode e si farà qualcosa di buono per il Servizio. E intendiamoci, proto, abbiamo scritto Servizio, con la maiuscola».
Anche un tale articolo non ottenne alcun risultato, ma, anzi, alcuni poliziotti più intraprendenti iniziarono a scrivere – sempre in forma anonima – direttamente al Capo della Polizia evidenziando problemi di vario genere, legati soprattutto alla qualità del servizio, ai soprusi dei superiori, al continuo mancato rispetto del riposo settimanale. Se da un lato (quello dei latori delle missive) si iniziò a capire che la strada intrapresa era quella giusta, dall’altro (quello del ministero) si dovette prendere consapevolezza di un problema che avrebbe potuto costituire la crisi del Corpo di Polizia sia in termini di risposta ai bandi di arruolamento, sia di obbedienza degli uomini agli ordini ricevuti.
Soprattutto nei Reparti Mobili (qui, una staffetta motorizzata durante un momento di pausa) il malessere del personale si sviluppò in modo rapido, a causa delle condizioni di vita che vi si conducevano all’interno
La consapevolezza e la necessità di aggregazione
Gli anni Sessanta costituirono il vero punto di svolta, e questo non solo per l’opera meritoria di un grandissimo Capo della Polizia quale fu Angelo Vicari. Una serie di concause (sociali ed economiche, ma anche organizzative) fecero sì che tutte le lagnanze, i malumori e le richieste di rinnovamento – fino ad allora presenti ma isolate tra loro – trovassero un elemento catalizzatore che mettesse finalmente in moto la macchina della smilitarizzazione.
Il “boom” economico che aveva travolto l’Italia a partire dalla metà degli anni Cinquanta creò un gigantesco volano per un’economia fino ad allora stagnante. Il benessere che iniziò a diffondersi nei vari strati della società italiana non toccò invece la Pubblica Sicurezza ove gli stipendi rimasero fermi; inoltre, le varie migliorie economiche che riguardarono il pubblico impiego, quali il riconoscimento dello straordinario, del lavoro festivo o notturno, continuarono a costituire un miraggio per i nostri Poliziotti, mettendo così in luce ancora di più il divario che li separava dagli altri comparti lavorativi. Di contro, il “nuovo” poliziotto non era più quel soggetto semianalfabeta, rozzo, manipolabile: il suo livello di cultura si era innalzato, tanto che ormai la maggior parte degli allievi era già in possesso della licenza elementare, molti addirittura di quella media e cominciavano a comparire anche i primi diplomati.
La qualità dei corsi di formazione stava raggiungendo livelli accettabili, anche se continuava a persistere un regolamento di servizio estremamente retrogrado, nel quale non si ravvisava ancora quella tanto invocata separazione tra l’essere un semplice militare ed essere invece un poliziotto. Era insomma come cercare di tenere alla cavezza un cavallo sempre più esuberante, nei confronti del quale le sole scudisciate cominciavano a non sortire più gli effetti voluti. Nelle caserme si intensificò ad esempio la stampa clandestina e la relativa diffusione di foglietti dal contenuto satirico verso i superiori e il servizio, poco più di una goliardata universitaria che però venne subito bollata come attività sovversiva e come tale perseguita. Tra le guardie si cominciava sempre più a parlare di un rinnovamento ormai non più rimandabile, ma si aveva paura di fare per primi quel tanto auspicato “salto nel buio”, tantopiù che le lettere anonime ai giornali stavano cominciando a non attirare più tutta quell’attenzione dei primi tempi: i tentativi di instaurare un dialogo con i propri superiori, sebbene fatti a norma di regolamento, sortirono quasi sempre il deferimento al tribunale militare e l’avvio di procedimenti disciplinari dall’esito pesante.
Quel “salto nel buio” trovò forma attraverso il primo, duraturo collante con alcune riviste del Corpo, fino ad allora allineate e coperte ma che, grazie alla lungimiranza dei loro nuovi direttori, iniziarono una rielaborazione critica del sistema-Polizia così come esistente fino ad allora, costituendo dunque quel catalizzatore tanto agognato tra la truppa e l’opinione pubblica. Quella che maggiormente si adoperò nel senso di una rottura con il passato fu “Ordine Pubblico” alla cui direzione si trovò Franco Fedeli, il nome che per primo divenne sinonimo di smilitarizzazione e sindacalizzazione del Corpo di Polizia. Di questo legame parleremo diffusamente tra breve.
Nel frattempo, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, il ministero dell’interno dovette fare i conti con un ulteriore fenomeno ritenuto preoccupante: il costante calo delle domande di arruolamento. La maggiore consapevolezza di se stessi grazie all’innalzamento culturale medio dei giovani, unitamente al trattamento economico decisamente più allettante che si poteva ormai trovare nella maggior parte degli impieghi dirottò le scelte professionali di molti ragazzi verso altre attività. Questo fenomeno di “diserzione silenziosa” dalla Pubblica Sicurezza durò più di un decennio, aggravato dal fenomeno della contestazione giovanile del Sessantotto (che mise in crisi interi comparti sociali, a partire da quelli più autoritari) e dall’avvento del terrorismo eversivo (che rese il mestiere di poliziotto se possibile ancora più rischioso). Il ministero corse ai ripari su due fronti: il primo, quello di immagine, venne ovviato mediante campagne di arruolamento più accattivanti, che mettevano in luce soprattutto l’aspetto di formazione professionale “a costo zero” e la possibilità per il neo arruolato di decidere il comparto di assegnazione nella Polizia; il secondo, quello economico, vide l’introduzione di piccole migliorie economiche sullo stipendio e del premio di arruolamento e rafferma di 850.000 Lire, una sorta di bonus di ingaggio riscuotibile nel triennio successivo all’arruolamento. Diciamo subito che il primo punto fallì miseramente il suo scopo: ben pochi vi credettero, anche perchè il giovane degli anni Sessanta aveva imparato a informarsi direttamente alla fonte, magari con amici o parenti già in Polizia. L’allievo continuava a ricevere una formazione di base e le sue preferenze di assegnazione verso reparti di proprio gusto (si pensi alla Polizia Stradale, alla Polizia alpina, al settore delle telecomunicazioni) venivano nella maggior parte dei casi disattese attraverso assegnazioni che prediligevano soprattutto i Reparti Mobili e Celeri ove la vita era se possibile ancora più dura e pericolosa rispetto agli altri comparti della P.S.. Restava il secondo punto (quello del premio di arruolamento), ma anch’esso si rivelò essere uno specchietto per le allodole: i premi venivano versati in ritardo, ammesso che si arrivasse alla prima rafferma senza inciampare in guai disciplinari che ne avrebbero minato l’ottenimento.
Dalla rivista “Orizzonti” del marzo 1962: ecco come il ministero cercò di porre rimedio al calo degli arruolamenti. Immagini felici e spensierate che facevano da contraltare a una situazione interna di tutt’altro stampo.
Rivelatasi inutile questa campagna di rilancio di immagine, il ministero corse ulteriormente ai ripari mediante una campagna informativa “mirata”, tramite l’invio personalizzato di brochure postali a tutti i giovani in età da arruolamento, ma iscritti nelle liste di collocamento e quindi allo stato disoccupati. Tale scelta non fece altro che attirare nella migliore delle ipotesi commenti ironici e battute di spirito, dando l’impressione che la pubblica sicurezza stesse raschiando il fondo del barile e facendo parlare i commentatori più disincantati di una “Polizia dei disoccupati”.
Nel frattempo nelle caserme il malumore continuava a salire: ne sono testimonianza i numeri relativi ai procedimenti disciplinari e ai deferimenti al tribunale militare. I poliziotti maggiormente bersagliati da questa prassi furono – come si è accennato – gli appartenenti ai Reparti Mobili e Celeri. La vita in questi reparti, a causa della peculiarità del servizio da essi disimpegnato, costringeva molto spesso a lunghe trasferte non retribuite in sedi lontane da quella di appartenenza, con ripercussioni negative sulla qualità della vita pratica: rancio approssimativo e, se fruito, consumato agli orari più assurdi; accantonamenti in luoghi di fortuna, talvolta costituiti da strutture completamente estranee all’amministrazione (stalle, conventi, navi, convogli ferroviari); orario di servizio del quale si conosceva solo l’inizio; scontri fisici con i manifestanti che diventavano sempre più pericolosi; obblighi di permanenza in caserma anche se liberi dal servizio comandato. Questi erano solo alcuni degli aspetti della vita “da celerino” e va da sé che la primo grossa pentola a pressione destinata a scoppiare fossero proprio questi reparti. E la miccia che fece esplodere tutto fu accesa di lì a pochissimo.
Gli accampamenti di fortuna durante i servizio di ordine pubblico: nella foto a sinistra, un casolare di campagna nel Polesine; in quella a destra, un hangar aeroportuale a Cecina…
Milano, 19 novembre 1969. In un’Italia già squassata da moti di piazza sempre più violenti ove al movimento studentesco ritenuto fino ad allora gestibile erano subentrati movimenti politici di area antagonista, il capoluogo lombardo vede profilarsi una nuova giornata al calor bianco. Tra le numerose manifestazioni in programma quel giorno, due sono quelle che preoccupano maggiormente: al Teatro Lirico di via Larga è in programma un incontro sul tema del caro-casa, alla presenza delle sigle sindacali più rappresentative e con un largo seguito di cittadinanza; contemporaneamente un gruppo dei cosiddetti “katanghesi” di estrazione marxista-leninista ha indetto un corteo di protesta affiancando gli studenti del movimento universitario, corteo che la questura dapprima non aveva autorizzato e poi aveva fortemente ridimensionato a livello di percorso. Le guardie del 3° Reparto Celere vengono dislocate in strada fin dalle 4 di mattina, secondo una prassi assolutamente priva di un reale senso operativo, cercando di creare una zona-cuscinetto tra le due manifestazioni che inizialmente sembra funzionare. Ma un inspiegabile errore nella gestione di quelle manifestazioni porta i katanghesi a “sforare” il percorso e a giungere in via Larga proprio mentre i partecipanti al congresso del “Lirico” stanno uscendo. Ne segue un marasma impressionante in cui i mezzi della Polizia si trovano “imbottigliati” tra via Larga e via Rastrelli: qualcuno perde la testa e partono le cariche mediante continui “caroselli” fatti con le Campagnole e i gipponi. In questo frangente la guardia Antonio Annarumma viene colpito alla testa da un palo da impalcatura scagliato a mo’ di giavellotto da un manifestante rimasto ignoto: morirà in ospedale nonostante il disperato intervento chirurgico cui venne sottoposto.
Milano, 19 novembre 1969. Nella foto in alto a destra, il gippone di Antonio Annarumma subito dopo essere stato colpito e privo di controllo si sta per schiantare contro una jeep del suo stesso reparto.
La morte di Annarumma divenne il detonatore di tutta la polveriera. Appresa la notizia del suo assassinio, le guardie del 3° Celere si ammutinarono, aggredendo i propri superiori e cercando di uscire con armi e mezzi per andare a farsi giustizia da loro. Il generale Giovan Battista Arista, Ispettore di Zona intervenuto per sedare gli animi, si buscò sputi e un paio di sganassoni venendo sottratto da altri ufficiali a un sicuro linciaggio. Si arrivò all’assurdo di vedere una caserma di Polizia circondata dai Carabinieri, inviati sul posto non si sa con quali ordini al riguardo. Solo alle 4 di mattina la situazione era almeno all’apparenza rientrata. I fenomeni di rivolta di quel giorno riguardarono anche alcuni altri reparti che da Milano erano stati inviati su altre manifestazioni: in particolare, due compagnie del C.A.P.S. di Cesena, rientrate da Bergamo, anche sulla scorta di notizie ingigantite che quantificavano in tre il numero di poliziotti uccisi quel giorno, cercarono di raggiungere la caserma Sant’Ambrogio per dare manforte ai colleghi ivi asserragliati.
Di fronte a una rivolta così palese, dalle intollerabili aggravanti specifiche, dopo un atteggiamento di iniziale indulgenza da parte del ministero – che aveva solo lo scopo di riportare la calma tra i reparti – decine di guardie, sottufficiali e perfino qualche ufficiale vennero deferiti al tribunale militare, destituiti, sottoposti a provvedimenti disciplinari o trasferiti d’ufficio altrove. A livello centrale si credette così di avere riconquistato la supremazia di comando, sottovalutando invece la reale portata del fenomeno che da quella data divenne sempre più incontrollabile. Inutile dire che la stampa – almeno quella non irregimentata – andò a nozze con queste proteste, incanalando nelle sue colonne tutte le proteste che i militari di P.S. ripresero a inviare.
D’altro canto, il 1969 è un annus horribilis anche per l’ordine pubblico: dopo quasi un decennio di relativa calma, senza più morti nelle piazze, in due distinte manifestazioni la Polizia torna a fare uso delle armi da fuoco. Si tratta di Avola e di Battipaglia. Nel primo caso (2 dicembre 1968) gli uomini del Reparto Mobile Sicilia Occidentale aprirono il fuoco dopo essere rimasti isolati tra i manifestanti che avevano cercato di sgomberare: si trattava di una manifestazione di protesta del bracciantato agricolo che si era visto discriminato nel salario a causa della insensata divisione delle campagne in due fasce, l’una ritenuta più redditizia dell’altra. Nel tentativo di rimuovere un blocco stradale, gli agenti si trovarono circondati da un folto gruppo di contadini che, grazie alla posizione dominante rispetto ai militari rimasti imbottigliati alla base di un argine, iniziarono a lanciare loro addosso di tutto. Partì la risposta armata, con due morti e numerosi feriti. Nel secondo caso (9 aprile 1969) un analogo tentativo di sgombero di un blocco stradale provocò altri due morti tra i manifestanti che protestavano per la chiusura di alcune fabbriche per la lavorazione del tabacco. In questo caso la reazione della popolazione fu ancora più violenta: il paese venne messo a ferro e fuoco, con l’assalto al commissariato di polizia che venne incendiato assieme a decine di mezzi di servizio.
Lungi dal cercare una giustificazione di fronte a ciò, la lettura di queste due stragi che possiamo dare non può prescindere dall’esasperazione in cui gli agenti di polizia erano calati, esasperazione resa ancora più acuta dalla sensazione di imminente pericolo per la propria vita in cui gli stessi erano volutamente mantenuti dai loro vertici. In questo senso abbiamo raccolto decine di testimonianze da parte di ex “celerini”, tutti concordi nel dire che non solo i comandi mantenevano gli uomini all’oscuro fino all’ultimo circa la tipologia di servizio che sarebbero andati ad effettuare, ma anche che, una volta sul posto, mettevano in giro artatamente notizie sulla presenza di bombe molotov, quand’anche di armi da fuoco, in possesso dei manifestanti. Simili voci venivano come sempre ulteriormente ingigantite a causa del frenetico passaparola tra commilitoni che aveva l’effetto di un incendio fra stoppie rinsecchite.
Il malcontento della Polizia e la contestazione giovanile
Il 1° marzo 1968 a Roma era accaduto qualcosa che era destinato a costituire l’elemento detonante anche all’interno delle caserme di polizia. A Valle Giulia l’ennesimo sgombero della facoltà universitaria di Architettura occupata dai collettivi studenteschi vide i loro appartenenti rivoltarsi contro le cariche della “Celere” che venne per la prima volta sistematicamente attaccata in quella che è stata consegnata alla storia con il nome di “battaglia di Valle Giulia”. Da un lato, gli agenti: abituati a imporre l’ordine senza eccessivi problemi, vennero colti in contropiede dalla reazione degli studenti. Dall’altro, questi ultimi: emerse per prima cosa il metodo “scientifico” con cui affrontarono le forze dell’ordine che vennero attirate nei giardini esterni della facoltà costringendole a separarsi e spesso a isolarsi. Fu quindi facile attaccare i singoli agenti, molti dei quali vennero feriti anche seriamente.
Valle Giulia, 1 marzo 1968
Questo bruciante smacco mise in luce innanzitutto l’impreparazione della polizia nell’affrontare i nuovi metodi operativi di protesta, ma anche – e soprattutto – il cambio generazionale che vedeva nei giovani studenti non più una massa informe da plasmare, ma un’entità pensante e organizzata. Ma avvenne anche altro. Tra gli stessi poliziotti (anch’essi non più quei “pecoroni” semi analfabeti del dopoguerra) presero ad attecchire in modo organico proprio quelle idee di rinnovamento che gli studenti propagandavano per il loro sistema, idee che avevano moltissimi punti in comune con la vita militare del poliziotto. Se infatti uno studente reclamava dai suoi docenti un sistema di insegnamento e valutazione più obiettivo, meno “baronale”, ma soprattutto più al passo coi tempi, l’agente di polizia rivendicava gli stessi concetti, soltanto applicati alla vita professionale.
Fu così che soprattutto nelle caserme (ma anche negli uffici territoriali) il malcontento iniziò a tradursi nella sempre maggiore diffusione di volantini contenenti sfottò, rimbrotti, critiche e anche qualche insulto diretto ai superiori e ai vertici politici ministeriali. In alcuni casi si andò oltre: a Milano alcuni mezzi del Reparto Celere vennero manomessi poco prima dell’uscita dell’autocolonna per un servizio di ordine pubblico; sempre a Milano, un contingente del Reparto Celere di Padova rientrato a sera inoltrata trovò la mensa di servizio chiusa: gli uomini sfondarono le porte di accesso e scaraventarono le suppellettili nel cortile. A queste forme di protesta collettive ne seguirono altre di natura individuale: un appuntato si ammanettò al proprio mezzo rifiutandosi di uscire se non lo avessero messo al corrente della tipologia di servizio che avrebbe dovuto affrontare; una guardia, rientrata semi-assiderata da un piantonamento notturno, scaricò un caricatore del mitra sul soffitto della caserma; altre iniziative di protesta riguardarono la qualità della mensa, con vassoi rovesciati o con il rifiuto di presentarsi a tavola, restando nella propria camerata; un gruppo di guardie sfilò nei corridoi della caserma “Adriatica” di Milano al grido di “Ho-Chi-Minh!”. Inutile dire che la risposta a tutte queste proteste fu l’esercizio ferro dello strumento della disciplina e del deferimento ai tribunali militari.
In questo panorama di forte tensione, come già accennato sopra, la rivista “Ordine Pubblico” diretta da Franco Fedeli divenne il catalizzatore naturale delle proteste dei poliziotti che in passato avevano tentato la stessa strada con la rivista ufficiale del Corpo, “Polizia Moderna”, che però non dette quasi mai spazio a questo genere di corrispondenza, tenendo fede alla bollatura di “stampa di regime” affibbiata dagli stessi militari e che la resero poco più di un rotocalco pubblicitario, dal quale doveva emergere sempre e comunque che in Polizia andava tutto bene e che la vita al suo interno era addirittura idilliaca. E invece, proprio una descrizione di prima mano di uno dei poliziotti arruolatosi nel 1951 e destinato a diventare uno degli esponenti di primo piano del movimento di smilitarizzazione (Enzo Giordani) recitava:
L’organizzazione militare aveva connotati di autoritarismo particolarmente odiosi, tanto che alcuni superiori si permettevano di arrivare alle offese e alle minacce personali. Gli epiteti più frequenti erano: “cafone”, “cretino”, “zappaterra”. Alcuni comandanti apostrofavano i loro subordinati con frasi di questo tipo: “Dovete stare a cuccia come i cani, contadini da quattro soldi!”. Una volta un alto ufficiale, alla presenza di un reparto schierato, arrivò a dire: “per licenziare la mia domestica occorrono 8 giorni di preavviso, per voi basta una giornata”. Un graduato poteva far imprigionare un poliziotto al tavolaccio con 15+30 (15 giorni di rigore, cioè di cella dopo l’orario di lavoro, e altri 30 senza libera uscita) senza rendere conto a nessuno. Chi osava reagire alle offese e alle ingiustizie non aveva scampo: o subiva il licenziamento o finiva davanti al tribunale militare.
A questo si aggiunga l’approvazione del nuovo Statuto dei Lavoratori (che aveva previsto significativi aumenti salariali) che però non era stato esteso anche alle Forze di Polizia. Di contro, ancora nel 1969 lo straordinario continuava a non venire riconosciuto, così come le indennità legate all’orario di servizio, lo stesso riposo settimanale continuava a essere concesso col contagocce, gli orari di servizio non consentivano un adeguato recupero delle energie psicofisiche del poliziotto, che si trovava ad affrontare un nuovo turno addirittura con un distacco di neanche due ore da quello precedente.
Dopo la morte della guardia Annarumma le proteste si diffusero con metodo in tutta Italia. Gli agenti non si sentivano più soli, ma potevano contare su una sempre maggiore sensibilità dimostrata dall’opinione pubblica sulla loro situazione. Insomma, sui muri che separavano le caserme dalla vita reale si stavano aprendo sempre maggiori brecce. La prima risposta del governo fu quella di aumentare sensibilmente gli stipendi dei poliziotti, concedendo loro altre piccole agevolazioni quali l’introduzione di un sistema grossolano di turnazione, il rispetto del riposo settimanale e della libera uscita, quest’ultima spesso negata soprattutto agli appartenenti ai Reparto Celeri. Ma non fu sufficiente. Gli agenti avevano ormai preso consapevolezza della loro “forza d’urto” che iniziava a essere considerata anche in ambito politico, con le prime timide aperture di senatori e deputati maggiormente “illuminati”. Di conseguenza, anziché diminuire, le proteste aumentarono.
A Torino il 21 ottobre 1971 un nutrito gruppo di agenti sfilò per le strade della città in uniforme e silenziosamente. Quello che oggi sembrerebbe un nonnulla, scatenò le immediate reazioni istituzionali. Gli agenti non avevano distribuito alcun volantino, non avevano inneggiato a nessuno né scandito slogan, non avevano nemmeno parlato con i passanti; si erano semplicemente limitati a fare una “passeggiata in divisa”. L’iniziativa venne tuttavia subito raccolta dalla stampa, le cui testate maggiormente orientate verso gli estremi schieramenti non persero occasione per strumentalizzare. Ancora una volta la mannaia disciplinare e giudiziaria si abbattè su quelle guardie, alcune delle quali vennero addirittura destituite: per tutti, sul fronte giudiziario venne formulata l’ipotesi di “attività sediziosa aggravata”, mentre su quello disciplinare scagliarono loro addosso praticamente l’intero regolamento del Corpo.
Ma furono proprio gli interessamenti della stampa e dei primi senatori (che evidenziarono l’assoluta esagerazione nella reazione punitiva del ministero) a far muovere i primi coordinamenti di poliziotti in tutta Italia. Già da subito vennero identificati con il termine di “carbonari” proprio per evidenziare la loro attività clandestina, a norma di legge addirittura illegale, tuttavia assolutamente necessaria per una svolta riformista davvero radicale nel regolamento del Corpo di Polizia. Da alcuni storici proprio il 21 ottobre 1971 viene indicato come la data di nascita ufficiale del movimento per la smilitarizzazione e sindacalizzazione della Polizia. E in questa ottica, in modo assolutamente naturale Franco Fedeli e il suo “Ordine Pubblico” divennero i portavoce ufficiali di questo movimento. Il primo passo significativo fu quello di limitare al massimo iniziative personali estemporanee, sia per le inevitabili ripercussioni sull’interessato, sia soprattutto per evitare di perdere quel minimo di credibilità che il nuovo movimento stava riscuotendo in ambito sociale e politico.
Franco Fedeli
Sul fronte ministeriale, le reazioni sdegnate proseguirono ancora per qualche anno. Non si poteva (o non si voleva) realmente concedere le migliorie richieste nel timore infondato di perdere il controllo sul “braccio armato dello Stato”, vero come è vero che un comandante di Reparto ancora nel 1975 definiva i propri uomini “gladiatori dello Stato, non guardie di Pubblica Sicurezza”. Si continuava a negare ad esempio il palese innalzamento culturale dei nuovi agenti evidenziato dal continuo calo di domande di arruolamento che ancora a metà degli anni Settanta continuava a costituire un grosso problema. D’altro canto, proprio in questo periodo era scoppiata l’emergenza del terrorismo eversivo e un diplomato ci pensava due volte prima di andare a rischiare la vita per centomila lire al mese. Ma ciò che maggiormente non veniva tollerato a livello centrale era l’inevitabile deriva politica che il movimento per la smilitarizzazione stava assumendo, con i partiti di sinistra che iniziarono a corteggiare gli agenti per un loro schieramento, grazie soprattutto alla presenza dei sindacati dei lavoratori che stavano guardando golosamente a questa fetta di torta in grigioverde.
Purtroppo ci si mise di mezzo ancora una volta la cronaca nera: il 12 aprile 1973 a Milano, durante una manifestazione di estremisti di destra prima autorizzata, poi negata, poi di nuovo autorizzata, una bomba a mano lanciata da un gruppo di “neri” colpisce in pieno la guardia di pubblica sicurezza Antonio Marino, 22 anni, che muore dilaniato. Ancora una volta le caserme di polizia esplosero in ennesimi tentativi di rivolta, come accadde quattro anni prima per il collega Annarumma. Sul fuoco della rivolta si mise a soffiare soprattutto il Partito Comunista, con una campagna di stampa “ad alzo zero” che da un lato sbattè in faccia all’opinione pubblica le “condizioni disumane di vita degli agenti”, dall’altro ribadì loro l’appoggio politico offerto affinchè le loro rivendicazioni potessero approdare finalmente in Parlamento.
Milano, 12 aprile 1973: il cadavere della guardia Antonio Marino giace a terra sfigurato dall’esplosione di una bomba
Fu così che il movimento riformista rischiò di naufragare ancora prima di avere issato le vele. Il fatto di essere stato involontariamente incasellato a livello politico fece allontanare dal suo interno molti poliziotti che non si identificavano in quella ideologia o che più semplicemente vedevano messo in serio pericolo il proprio posto di lavoro. Inoltre il movimento non riuscì a controllare quelle iniziative personali di protesta che vanificarono in parte i suoi sforzi di legittimazione. Nell’autunno del 1973 proprio Roma vide due di queste iniziative: nella prima un centinaio di agenti sfilò a volto coperto in piazza Venezia scandendo slogan dal chiaro contenuto politico; nella seconda vi fu addirittura una marcia di protesta sempre da piazza Venezia fino a piazza Navona: in quest’ultima si assistette addirittura a scene boccaccesche, con le guardie inseguite dai loro superiori. Contemporaneamente in numerose città (soprattutto Torino, Milano e Roma) le radio di servizio montate sulle autopattuglie vennero utilizzate per trasmettere messaggi e slogan a favore della riforma. In occasione dell’assassinio dell’ennesimo poliziotto per mano brigatista (la guardia Claudio Graziosi, 1977), le volanti della questura compirono numerosi passaggi a sirene spiegate attorno al Viminale, sede del ministero dell’interno. E già due anni prima, quando venne assassinata la guardia Giuseppe Marchisella, fu proprio l’intervento del movimento riformista a scongiurare reazioni inconsulte da parte dei colleghi di questo agente, reazioni che vennero subitaneamente arginate.
Tutte queste fiammate di protesta, che avevano ormai assunto la connotazione di proteste organizzate, non poterono più essere sottaciute dal ministero soprattutto per il fatto che dalle periferie gli stessi prefetti segnalavano con sempre maggiore insistenza la gravità del fenomeno che dall’interno delle caserme era ormai diventato incontrollabilmente di dominio pubblico. Insomma, sanzioni disciplinari e procura militare non potevano più fare molto perchè per ogni poliziotto punito altri tre aderivano al movimento. In una riservata ministeriale il prefetto di Milano fu chiaro nel mettere nero su bianco la situazione, elencando le rivendicazioni degli agenti:
– Indignazione e sgomento in conseguenza del decesso della Guardia Marchisella e per le altre forme di efferata criminalità per le quali le guardie sono costrette a pagare un contributo continuo di sangue e di sacrifici.
– Insufficiente preparazione professionale ricevuta dall’Amministrazione; mancanza di addestramento alle armi e di allenamento continuo al tiro; mancanza di preparazione psicologica.
– Condizioni di inferiorità rispetto alla delinquenza per dover sparare sempre per secondi, pena
l’incriminazione da parte del magistrato.
– L’eccessivo rigore formale imposto dalla disciplina militare e dalla vita di caserma, soprattutto se
confrontati alla mancanza di adeguata preparazione e di adeguate istruzioni tecniche rispetto al servizio affidato. In conseguenza: richiesta che l’Amministrazione esamini con favore il problema della smilitarizzazione.
– Insufficienza delle retribuzioni, soprattutto se si considera il tasso di svalutazione successivo all’ultimo aumento e le ritenute d’imposta gravanti con la riforma fiscale.
– Richiesta di esame favorevole da parte del Ministero per modificare le norme di legge che impediscono la costituzione del sindacato della polizia.
– Richiedere al Ministero della Difesa di fare vigilare gli aeroporti dalle Forze Armate dell’Aviazione.
Questo contributo, agli atti ministeriali, fu una pietra miliare: per la prima volta un alto funzionario stava comprendendo la legittimità delle rivendicazioni, esortando egli stesso il ministero a una valutazione più serena delle stesse.
Nel 1976 a Padova accade qualcosa di incredibile. Se il ministero riteneva che il malcontento riguardasse la truppa, nell’agosto di quell’anno presso il 2° Reparto Celere scoppia quello che passerà alla storia come il “caso Margherito”. Facciamo rinvio alla dettagliata analisi di quei fatti, già pubblicata su questa pagina.
E nel 1977 il movimento trovò un altro valido interlocutore proprio nell’allora ministro dell’Interno, Francesco Cossiga.
L’escalation della violenza negli scontri di piazza e del terrorismo eversivo raggiunse l’apice proprio in quell’anno, il 1977, durante il quale numerosi poliziotti vennero uccisi sia durante servizi di ordine pubblico, sia dai terroristi eversivi. Questi nuovi fatti criminosi impressero un’ulteriore spinta evolutiva al movimento per la smilitarizzazione che vide sorgere in modo del tutto spontaneo gruppi clandestini sempre più numerosi, con programmi articolati che trovarono presa negli ambienti “di palazzo”. Di contro, nelle articolazioni istituzionali più intransigenti e militariste che dovevano contrastare lo sviluppo del movimento iniziarono a svilupparsi crepe sempre più numerose e profonde: il disagio dei poliziotti, amplificato sia dalla stampa nazionale che da quella interna, era un fenomeno che non poteva più essere negato, né tantomeno tenuto nascosto. La rivista “Ordine Pubblico” e il suo direttore Franco Fedeli veicolarono questo fenomeno in modo certosino, con un lavoro di coordinamento monumentale che sopravvisse ai vari tentativi di boicottaggio e di censura: Fedeli non era più solo, attorno a lui si era formato un collegio di collaboratori (sette in tutto) che non lo lasciarono mai solo e che divenne il primo baluardo agli ormai vani assalti istituzionali. Dopo il “caso Margherito” di cui si è accennato sopra, anche taluni procuratori militari adottarono una linea più “morbida”, ben comprendendo che il movimento sarebbe stato a breve ufficializzato e che la sua marcia sarebbe divenuta inarrestabile. In questa sede va evidenziato un particolare: “Ordine Pubblico”, fondato nel 1952 e mai assurto a rivista ufficiale del Corpo, aveva ab origine mantenuto posizioni ancora più conservatrici rispetto a “Polizia Moderna”. Solo dalla fine degli anni Sessanta la linea editoriale mutò radicalmente, attestandosi su posizioni democratiche e riformiste. Lo stesso Franco Fedeli potè muoversi con maggiore libertà proprio perchè inattaccabile dall’interno, non essendo egli un appartenente al Corpo bensì un giornalista di professione. Ecco dunque che, se volessimo adottare come esempio del ruolo espletato dalla rivista soprattutto all’inizio degli anni Settanta una figura “resistenziale”, potremmo paragonare la sua attività a quella di una staffetta partigiana che teneva il collegamento tra i vari gruppi nascosti in montagna. E proprio con strategia tipicamente partigiana si comportarono i gruppi di “carbonari”, i cui nemici erano quegli stessi colleghi delle Squadre Politiche delle Questure o addirittura coloro i quali si erano arroccati su posizioni militariste e che facevano il doppio gioco, fungendo da delatori: erano costoro i soggetti maggiormente pericolosi dai quali guardarsi con estrema attenzione.
Pubblichiamo un’intervista rilasciata da Franco Fedeli nel 1977 al quotidiano “La Stampa”.
Pagina 7
(07.02.1977) StampaSera – numero 25
Intervista con il combattivo direttore di “Ordine pubblico,, Franco Fedeli: “C’è troppa tensione, la polizia in continuo stato d’attacco ha paura. Oggi, in Italia, il poliziotto è come il figlio di certe famiglie separate, dove i genitori si odiano a morte: va dal padre, e dice male della madre: va dalla madre, e dice male del padre. Con tutte le conseguenze che ne derivano, non ultime quelle di ordine psicologico. Insomma i poliziotti escono la mattina dalle caserme, dove sino a quel momento sono stati gestiti dagli ufficiali, per entrare in un commissariato o in una questura, dove vengono gestiti dai funzionari di polizia. Due dirigenze di diversa formazione, estrazione, mentalità. Conseguenza: sono sempre tra l’incudine e il martello e si abituano a quel tipo di gesuitismo classico dei figli di molte famiglie separate. Bisogna risolvere il problema fondamentale: quello della riunificazione dei ruoli della dirigenza. In uno strumento così scassato, ci vuole una sola dirigenza ». Forse nessuno, in Italia, conosce dal di dentro i problemi della polizia come Franco Fedeli. E’ stato a lungo il «portavoce» degli agenti con il mensile «Ordine pubblico». Licenziato brutalmente tempo fa, dopo una serie di aspre polemiche sul sindacato di polizia, Fedeli si è subito tuffato in una nuova impresa editoriale che, assicura, «darà più fastidi della prima ». Tra una settimana, esce infatti « Nuova polizia e riforma dello Stato», 80 mila copie di tiratura, diffusione nazionale, Napoleone editore, Fedeli direttore con collaboratori come Rodotà, Giugni, Amato, Neppi Modona. E’ domenica. Parliamo con Fedeli nel suo appartamento di corso Trieste mentre la città, che si era appena riavuta dai tragici fatti di piazza Indipendenza, è di nuovo sotto choc per una nuova serie di episodi di violenza rivendicati da un fantomatico gruppo “Mara Cagol”. Sono tanti: dalle bombe sul treno a quelle contro i commissariati. Poi c’è il fatto più sconcertante: due vigilantes-truffatori che cercavano scampo, con la fuga, alle loro bravate spingono una pattuglia di poliziotti a sparare su cittadini innocenti. « Colleghi, stanno scappando, fate qualcosa » hanno gridato i vigilantes e i poliziotti, senza pensarci un attimo, hanno sparato contro l’auto su cui erano tre ragazzi. Vuoi spiegarmi, chiedo a Fedeli, come è possibile una reazione cosi immediata e assurda? Per poco non c’è scappato il morto. «C’è un tale stato di tensione che può accadere di tutto. Abbiamo portato la tensione e la paura oltre i limiti di guardia. Quindi, nessuno stupore se ci troviamo di fronte a conseguenze in apparenza inspiegabili, che hanno cause precise, vicine e lontane ». Quali sono le cause, secondo te, e quali le responsabilità? « Se muore il poliziotto, si fa la campagna contro la magistratura. Se muore il magistrato, allora la colpa è delle forze di polizia. E’ un rito che si ripete da sempre, con una monotonia grave ed esasperante, e che finisce inevitabilmente con il solito dibattito in Parlamento, dove qualcuno invoca aggravanti di pena. Poi, niente. Nessuno si occupa più del problema, sino a quando non si verifica un nuovo grave episodio. Nessuno vuole affrontare il toro per le corna, varando presto e bene un piano organico che contempli tutta una serie di provvedimenti indispensabili: dalla polizia, ai codici, alla magistratura, alle carceri. Una riforma vera dell’intero apparato della giustizia ». Per Fedeli, il «caso» del poliziotto che spara subito, rispondendo con le armi al grido di due sconosciuti contro gente innocente e inerme, è «un caso purtroppo tipico dello stato in cui vivono oggi sia gli agenti sia i cittadini. Il poliziotto è facile preda di qualsiasi suggestione. Si sente in continuo “stato di attacco”». Oggi, nella polizia, si rischia la morte anche in borghese, non più solo in divisa. Perché? Fedeli vuol subito distinguere due funzioni: il servizio di ordine pubblico e il servizio di polizia giudiziaria. A suo giudizio, il poliziotto della giudiziaria deve per forza essere in borghese e «difficilmente muore». Per i servizi di ordine pubblico, il discorso cambia radicalmente: «L’impiego indiscriminato di poliziotti in borghese diventa rischioso e inopportuno — spiega Fedeli — durante una manifestazione, prendere uomini in borghese e metterli tra i manifestanti significa esporli a rischi altissimi. Il rischio può essere accettato se gli agenti hanno solo l’incarico di osservare e poi riferire. Ma se viene dato agli agenti l’incarico di intervenire, allora il pericolo diventa grande perché si trovano sbattuti in mezzo a una marea di gente già tesa per conto proprio e che, d’improvviso, si trova anche “il nemico dentro casa”. Non vederli in divisa, poi, contrariamente a quanto si pensa, aumenta l’aggressività del dimostrante». Che si può fare per migliorare la situazione degli agenti? «Bisogna rendere concorrenziale questo mestiere. Evitare cioè che in polizia entrino in maggioranza tutti coloro che si seno visti esclusi da altre prospettive di lavoro, compresa l’emigrazione. Bisogna fare entrare in polizia gente con almeno la licenza media: e bisogna anche che si facciano, per la prima volta, scuole speciali per formare il poliziotto, tenendo presente che per formare un tornitore ci vogliono due anni mentre per formare un poliziotto oggi bastano 6 mesi». Un’altra domanda. A che punto sono le vicende del sindacato di polizia? «In questi giorni, in tutta Italia, si sta portando a termine la campagna-adesioni alla federazione unitaria. Siamo all’ottanta-novanta cento. Il sindacato di polizia è una realtà che nessuno potrà disconoscere».
Luca Giurato
La spontaneità del movimento necessitava anche di un coordinamento operativo “sul campo”, proprio per evitare che l’ingenuità soprattutto delle guardie più giovani li ponesse su posizioni compromettenti. Fedeli individuò nei sottufficiali più anziani – che avevano vissuto sulla loro pelle gli effetti dell’esasperato militarismo degli anni Cinquanta – quell’anello di collegamento e di autodisciplina del movimento: fu questa categoria a rischiare maggiormente, poiché il loro compito di diffusione della propaganda riformista incardinava in pieno il reato di attività sediziosa. Soltanto a riforma avvenuta vi furono le prime ammissioni sulle strategie di incontro, riunione e diffusione ideologica adottate dai “carbonari”: volantini e ciclostyle scambiati nelle buie e fumose sale dei cinema; incontri casuali in zone isolate tra gruppi di non più di tre persone; continui spostamenti cambiando di continuo i mezzi di trasporto, per mettere in difficoltà eventuali pedinatori; divieto assoluto di discussioni con estranei, ancorchè colleghi, soprattutto all’interno di uffici e caserme nonché dell’uso del telefono per comunicare tra di loro. I “carbonari” ricorsero anche all’aiuto di insospettabili familiari, addirittura dei figli minori, per le loro comunicazioni: il luogo stabilito per una riunione veniva improvvisamente cambiato anche tre o quattro volte, spesso all’ultimo minuto. Secondo la tipica strategia partigiana, adottarono anche i nomi di battaglia per rendere ancor più difficoltosa la loro individuazione. Nonostante questo, furono in molti a cadere nelle trappole investigative tese dalle questure, pagando con il carcere e la destituzione dal Corpo. Va però detto che, dopo la riforma, molti di essi vennero reintegrati nei ruoli ed ebbero la carriera ricostruita.
Credendo di risolvere (o quantomeno di arginare) il fenomeno, il Ministero ricorse a massicci e frequenti trasferimenti d’ufficio del personale, soprattutto di quello inquadrato nei Reparti Celeri ove il malumore era maggiormente diffuso. Una simile strategia si rivelò invece un autentico boomerang poiché i militari trasferiti, lungi dal discostarsi dalle idee “sovversive”, si fecero a loro volta portavoce con i nuovi colleghi nelle sedi di assegnazione, contribuendo così alla diffusione ancora più capillare delle idee riformiste.
Il collegamento con gli ambienti politici e sindacali fece fare al movimento un primo, importante passo in avanti sulla strada della sua legittimazione. Nel 1973 venne fondato il Comitato studi per il riordinamento della polizia, divenuto operativo all’inizio del 1974 e del quale facevano parte non solo appartenenti al Corpo inquadrati nei vari gradi, ma anche avvocati, magistrati, parlamentari e dirigenti sindacali del comparto civile. La costituzione di un simile Comitato – di cui Fedeli dette risalto su “Ordine Pubblico” – ebbe il merito di stoppare in gran parte le iniziative repressive che il ministero continuava pervicacemente a portare avanti: non si trattava più di avere a che fare con un manipolo di “guardiacce” anarchiche, facilmente estirpabili; ora c’era di mezzo la politica e la magistratura e in questi ambienti il “muro contro muro” aveva sempre sortito effetti deleteri.
E proprio grazie a questa importante novità, alla fine del 1974 il movimento di riforma uscì parzialmente dall’ombra tenendo le proprie riunioni in modo pubblico, sebbene accuratamente sorvegliato dagli Uffici Politici. Questa parziale omologazione contribuì in modo significativo ad aumentare il numero di aderenti al movimento, adesso non più spaventati dalle ritorsioni interne. Le strutture clandestine dei “carbonari” vennero pian piano smantellate e sostituite da comitati di coordinamento ai cui vertici vennero collocati personaggi di primo piano, proprio per “blindarli” da attacchi e tentativi di destrutturazione. Non si pensi infatti che gli antimilitaristi fossero solo funzionari ministeriali: in seno al Corpo continuavano a sussistere guardie e sottufficiali apertamente contrari alla smilitarizzazione e sindacalizzazione, a loro volta costituitisi in comitati e cellule di disturbo che spesso tentarono di mettere i bastoni tra le ruote anche nelle riunioni dei loro antagonisti. Non ebbero tuttavia il tempo di organizzarsi come lo ebbe il movimento, né tantomeno riuscirono a trovare referenti politici che facessero acquistare loro il peso della controparte: il loro ruolo non riuscì quindi ad andare oltre roboanti proteste da caserma e qualche incursione nei comitati.
E il 1974 è anche l’anno della pubblicazione su “Ordine Pubblico” del primo manifesto programmatico per la riforma della Polizia. Ne riportiamo un estratto, così come estrapolato dalla rivista citata:
L’Istituto di Polizia dev’essere inteso come organizzazione civile al servizio della legge; gli appartenenti alla Polizia debbono godere di tutti i diritti civili concessi ai lavoratori della Repubblica; in particolare debbono essere tutelati da norme che non deroghino, in forma restrittiva, dallo Statuto del personale civile dello Stato, di cui debbono far parte, per cui le deroghe vigenti dovranno essere abolite, lasciando intatti i vantaggi già acquisiti; l’orario di lavoro non deve superare per ogni turno di servizio le 8 ore giornaliere, salvo prestazioni di carattere straordinario, regolarmente remunerate; gli appartenenti alla Polizia debbono far parte della medesima organizzazione, con esclusione, quindi, di elementi estranei, come ad esempio, funzionari dell’Amministrazione civile dell’Interno; i rapporti tra cittadino e Polizia debbono essere improntati a mutuo rispetto, ma i danni e le offese arrecati agli appartenenti alla Polizia, nel compimento del loro dovere, debbono trovare pronta, decisa ed efficace tutela; i rapporti Stato- Polizia-Sindacato debbono essere regolati da precise norme di legge, da cui risultino le autolimitazioni imposte dagli stessi appartenenti alla Polizia escluso dai mezzi tradizionali di lotta; gli appartenenti alla Polizia si impegnano alla difesa delle istituzioni democratiche repubblicane e alla tutela dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai cittadini; gli appartenenti alla Polizia non possono essere distolti dai compiti di istituto per essere assegnati ad incarichi diversi da quelli previsti dalla legislazione che li riguarda. L’azione della polizia dev’essere sempre caratterizzata dalla più assoluta neutralità e nulla dovrà essere fatto a beneficio esclusivo di un partito, di una ideologia o di una fazione di cittadini a danno degli altri; l’appartenenza alla Polizia costituisce distinzione onorifica, per cui la perdita di fiducia da parte dei cittadini può provocare la esclusione dal servizio attivo; il reclutamento e le specializzazioni debbono essere effettuati in base a rigidi criteri di accertamento sulle capacità intellettuali e sulle doti morali e fisiche degli aspiranti, mentre, non dovranno essere motivo di esclusione le discriminazioni di carattere religioso o politico; l’addestramento nelle scuole di Polizia dovrà essere adeguato alla realtà del Paese ed alle esigenze strettamente tecnico-professionali in modo da consentire una vera competitività per coloro che intendano intraprendere la carriera dell’agente di Polizia; il comportamento degli appartenenti alla Polizia deve essere tale che essi con giuramento dovranno impegnarsi alla autotutela dell’Istituto per emarginare prontamente quanti, «indegni», possano ledere il prestigio e l’elevata funzione di cui sono investiti, per cui approvano la proposta ristrutturazione della P.S. in «CORPO DI POLIZIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA».
Inutile dire che il ministero rispose ribadendo l’assoluta illegalità di questi movimenti e imponendo a questori e prefetti la massima attenzione nel monitoraggio di quella che veniva ostinatamente ancora ritenuta attività sediziosa.
A queste minacce il movimento riformista rispose con la prima assemblea ufficiale indetta presso l’hotel Hilton di Roma il 21 dicembre 1974. Fu un autentico salto nel buio, il cui esito – per nulla scontato – mandò in fibrillazione gli stessi organizzatori, consapevoli di giocarsi il tutto per tutto. L’assemblea fu invece un successo che andò oltre le più rosee previsioni: vi parteciparono più di 2000 poliziotti giunti nella capitale da tutta la Penisola. Il comitato costituì proprio in quell’occasione il Comitato Nazionale di Coordinamento, vero fulcro dell’attività poiché unico anello di congiunzione tra l’interno del Corpo e le compagini politiche e sindacali esterne. Se si può dunque fissare una data a partire dalla quale cessò la “carboneria” fu proprio quella del 21 dicembre 1974.
A partire dal 1975 si potè quindi elaborare quell’iniziale manifesto programmatico alla luce del sole. Il passo più importante fu la sua traduzione in otto punti che, in un momento successivo, andarono a costituire l’impalcatura della 121/81. Li riportiamo così come indicati dalle fonti:
Abrogazione dei decreti 31.7.1943 e 24.4.1945.
Istituzione del servizio civile di polizia con l’unificazione dei ruoli degli ufficiali e dei funzionari di p.s. con medesime attribuzioni.
Riconoscimento della libertà sindacale con quelle modalità dettate dalla peculiarità delle funzioni esercitate, tra cui il non ricorso al diritto di sciopero.
Radicale riorganizzazione dell’Istituto che si basi su un ampio decentramento; istituzione o potenziamento dei commissariati urbani di quartiere e dei posti di polizia; presenza capillare del tutore della legge, in modo da stabilire un rapporto nuovo e di collaborazione tra cittadino e poliziotto, così da esaltare il compito non soltanto di repressione e di controllo, ma soprattutto di prevenzione.
Trasferimento dei compiti burocratici e amministrativi non di pertinenza della p.s., agli enti locali e alle amministrazioni periferiche dello Stato.
Divieto d’impiego del personale in compiti estranei alle funzioni di polizia.
Riforma del reclutamento e delle scuole di pubblica sicurezza; promozione di tutte quelle iniziative didattiche che garantiscano un alto livello di qualificazione e specializzazione professionali.
Adeguamento del trattamento economico e normativo a quello di altri dipendenti dello Stato che hanno compiti meno rischiosi.
Il ministero si rese conto di avere perso il controllo repressivo su quella che a tutti gli effetti era diventata un’inarrestabile valanga. Le circolari inviate dal centro alle periferie non imponevano più i metodi draconiani di trasferimento e di deferimento alla procura militare, ma si limitarono a caldeggiare una sorveglianza discreta del movimento e dei suoi aderenti, al fine di evitare derive anticostituzionali.
Come sempre, fu la cronaca a imprimere una profonda accelerazione alla riforma della Polizia: dopo la “spallata” al sistema esplosa a Padova nell’agosto 1976 con il già citato “caso Margherito”, l’esplosione delle piazze italiane del 1977 e la strage di via Fani dell’anno successivo fecero finalmente approdare in sede parlamentare le bozze della legge di riforma che venne perfezionata tra il 1980 e i primi mesi del 1981.
Tutto il resto è storia nota. Questa esegesi, che non ha certo la presunzione di essere stata completamente esaustiva, ha come unico scopo quello di evidenziare l’immensa mole di lavoro e di rischio sopportata da tantissimi colleghi che hanno reso l’apparato della Polizia italiana quello che è oggi, traghettandola tra mille difficoltà da un ordinamento borbonico a uno diametralmente opposto, consegnando le nuove generazioni di poliziotti a un futuro più radioso.
Bibliografia
Andrea Di Michele, Storia dell’Italia repubblicana(1948-2008), Milano, Garzanti, 2008.
Alberto Bernardi, La Riforma della polizia. Smilitarizzazione e sindacato, Torino, Einaudi, 1979.
Angelo D’Orsi, Il potere repressivo. La polizia. Le forze dell’ordine italiane, Milano, Feltrinelli, 1972.
Annibale Paloscia, I segreti del Viminale, Roma, Newton Compton, 1994.
Cesare Medail, Sotto le stellette, Torino, Einaudi, 1977.
DIREZIONE GENERALE DI P.S., Manuale di istruzione militare e professionale per allievi guardie e guardie di P.S., Roma, Palombi, anni 1949 – 1952 – 1956 – 1960 – 1966 – 1971.
Ennio Di Francesco, Un commissario. L’odissea di un funzionario dello Stato, Roma, Castelvecchi, 2013.
Franco Fedeli, Da sbirro a tutore della legge. L’emarginazione, i problemi della famiglia, la tensione, i pericoli di un mestiere difficile nelle lettere dei poliziotti, Napoleone, Roma, 1981.
Giuseppe Carlo Marino, La repubblica della forza. Mario Scelba e le passioni del suo tempo, Milano, Franco Angeli, 1995.
Giovan Battista Arista,Polizia, Italia, Ufficio addestramenti e studi, 1958.
Giovanna Tosatti, Storia del Ministero dell’Interno. Dall’Unità alla regionalizzazione, Bologna, Il Mulino, 2009.
Giuseppe Carlo Marino, La repubblica della forza. Mario Scelba e le passioni del suo tempo, Milano, Franco Angeli, 1995.
Riccardo Ambrosini, Le parole di una vita. In ricordo di un poliziotto che voleva un Paese migliore, Roma, DDE editrice, 2000.
Romano Canosa, La polizia in Italia dal 1945 ad oggi, Bologna, Il Mulino, 1976.
Sergio Bova, Il controllo politico delle forze armate. L’organizzazione della difesa dello stato repubblicano, Torino, Einaudi, 1982.
Valentino Giacomin– Fabio Frongia, La Polizia non ringrazia. Il caso Margherito, Padova, New Press, 1976.
La riforma della polizia. Progetti di legge ed iter parlamentare della legge 1° aprile 1981, n. 121., Roma, Camera dei Deputati, 1983.
Rivista “Polizia Moderna”, varie annate.
Rivista “Ordine Pubblico”, varie annate.
Rivista “Fiamme d’Oro”, varie annate.
Ordinamento e Regolamento del Corpo delle Guardie di P.S., anni 1949 – 1956 – 1960 – 1965 – 1972 – 1979
Ordinamento e Regolamento della Polizia di Stato, anni 1983 – 1990 – 2016
Michele Di Giorgio, Per una polizia nuova Il movimento per la smilitarizzazione e per la riforma della Pubblica Sicurezza in Italia (1969-1981), tesi di dottorato Università Ca’Foscari Venezia, 2016.
Si ringraziano infinitamente l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e gli innumerevoli colleghi per le testimonianze orali fornite nel corso delle ricerche.
Edited by giacal - 5/10/2022, 19:03. -
.
Categoria: Corpo delle Guardie di P.S.
Anno: 1944, 2 novembre
Luogo: Roma
Oggetto: decreto luogotenenziale n° 365 di ricostituzione del Corpo delle Guardie di P.S. a firma Pietro Badoglio
Fonte: Bollettino Ufficiale del Ministero dell'InternoAttached Image. -
.
Categoria: Smilitarizzazione
Anno: 1977
Luogo: Roma
Oggetto: una foto molto particolare e - per i tempi - anche pericolosa. Siamo agli albori del sindacato, quando i comitati di base venivano visti come riunioni di sovversivi
Fonte: calendario storico della Polizia di Stato 2021Attached Image.
Il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (1944 - 1981) |
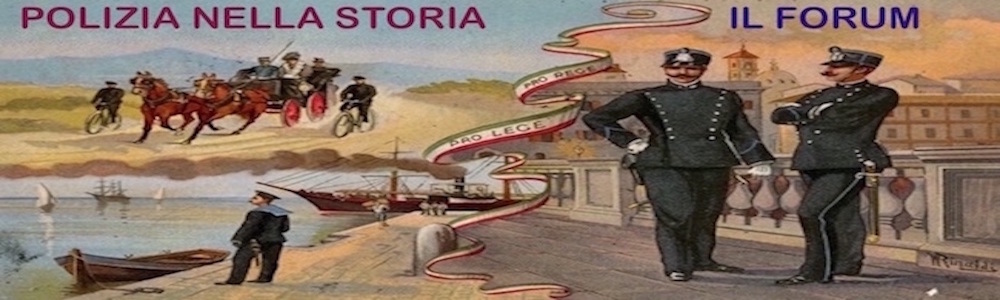




 Anonymous
Anonymous
